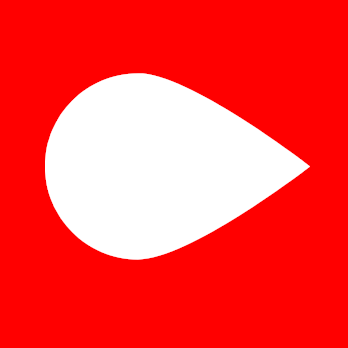Tratteggiare l'incomprensibile
Il weird, il bianco e nero, l'orrore. Le opere di Howard Phillips Lovecraft brillano anche nelle loro trasposizioni a fumetti, da Erik Kriek a Yellow Tanabe.
Howard Phillips Lovecraft è stato uno scrittore di racconti di genere, vissuto a inizio ‘900 in quel New England che fa così spesso da sfondo alle sue storie. Nato nel 1890 a Providence, inizia la sua carriera di scrittore pubblicando storie weird su rivista, per poi dedicarsi più o meno scientemente alla costruzione di una mitologia che avrebbe segnato l’immaginario collettivo nei decenni a venire e soprattutto alla canonizzazione di un nuovo genere letterario: l’orrore cosmico, ben sintetizzato nell’apertura de Il richiamo di Cthulhu, tra i suoi racconti più famosi.
Al di là della sua permanenza nella cultura di massa, che ne ha fagocitato gli elementi base della scrittura e ne ha spesso traviato o frainteso l’iconografia, credo sia interessante, oggi, fermarsi a riflettere sull’opera lovecraftiana. E in particolar modo che sia interessante farlo attraverso la lente d’ingrandimento dei suoi (numerosi) adattamenti a fumetti. Questo in primo luogo perché alcune peculiarità delle sue narrazioni lo rendono un case study ideale per riflettere sulla questione degli adattamenti tout court: a lungo si è creduto che la chiave dell’estetica lovecraftiana fosse la non-visualizzabilità, pertanto è perlomeno singolare la quantità di tentativi di trasposizione verso linguaggi prettamente visivi quali il fumetto, il cinema e, più di recente, il videogioco.
Analizzare questi adattamenti ci permetterà quindi di focalizzare l’attenzione sul dato formale – troppo spesso trascurato nella narrativa contemporanea che proprio per questo non riesce a farsi letteratura, come ben esposto da Walter Siti in Contro l’impegno (Rizzoli, 2021) – tanto dei racconti “originali” quanto delle loro riproposizioni cross-linguistiche. Gradito effetto collaterale di questa esplorazione sarà, si spera, il sorgere di una riflessione più ampia sulle modalità e le finalità dell’adattamento a fumetti, uno dei fenomeni editoriali più rilevanti e al tempo più preoccupanti dell’esplosione del graphic novel.
Il fumetto è un linguaggio giovane, vittima innocente di un pregiudizio che lo voleva arte ancillare buona al più come intrattenimento spicciolo. Non c’è da stupirsi: nonostante il visual turn e la sempre crescente predominanza che le immagini ricoprono nella nostra società, c’è un certo analfabetismo quando si tratta di linguaggi visivi, radicato fin dalla struttura di programmi scolastici che non prevedono un’adeguata attenzione all’insegnamento della decodifica di ciò che è visuale. D’altro canto, per leggere un testo servono sforzo e competenza, i disegni invece parlano da soli, “è risaputo”. E se di conseguenza l’idea dominante, per quanto errata, è stata che leggere un fumetto è più facile di leggere un libro, il passo verso l’affermazione che il valore del primo è intrinsecamente inferiore a quello del secondo è piuttosto breve.
L’affermazione del graphic novel e l’ingresso della letteratura disegnata nei circuiti delle librerie generaliste hanno posto un freno a queste percezioni dando al fumetto, almeno a quello per adulti, un’aura di legittimità inedita (che questa legittimità abbia a sua volta generato una maggior consapevolezza culturale è però tutto da verificare). Tuttavia nel recente rinnovato interesse da parte del mercato per lettrici e lettori giovani, che si è tradotto nell’esplosione della proposta di fumetti per young adult prima e per bambine e bambini poi, si riscontra ancora e forse con maggior forza il pregiudizio, particolarmente evidente nell’abbondanza di titoli a tema, di biografie d’artista e, per tornare alla questione, di adattamenti di classici della letteratura. Titoli che sono il più delle volte sciatti, esteticamente irrilevanti, formalmente inconsistenti.
Viene da chiedersi chi sia il lettore implicito di questi testi. Perché troppo spesso la risposta pare essere lo “studente svogliato che legge troppa poca narrativa o non ne legge affatto, e quindi piuttosto di nulla che almeno legga i fumetti”. Meglio poi se questi graphic novel permettono a suddetto studente di imparare qualcosa, nell’accezione più pedante e didascalica del termine, come la vita di Frida Kahlo o la strage di Piazza Fontana. Oppure, se un po’ si desidera mascherare l’uso strumentale di un testo comunque inteso come tramite per qualcosa al di fuori dello stesso, almeno che questi graphic novel siano trasposizioni di opere letterarie: in fin dei conti ogni stratagemma è valido per far arrivare la grande letteratura all’attenzione monopolizzata dal piccolissimo schermo di queste generazioni svogliate. Ed ecco quindi il fiorire di adattamenti che sono quasi sempre riduzioni, prodotte in serie più che scritte, con un approccio che tradisce e sminuisce tanto il valore intrinseco del linguaggio fumetto quanto il classico che si ripropone di rendere visuale, scarnificandolo fino a che ciò che ne resta non è che la trama accompagnata da qualche (brutto) disegno. Del dato formale è scomparsa ogni traccia.
È necessario invece tenere sempre a mente che ogni adattamento è un atto di riscrittura, quindi in sé un atto di scrittura; di creazione artistica, in altre parole. E va quindi valutato in se stesso, secondo il valore estetico che gli appartiene. Credere che ci sia del valore in una sciatta trasposizione a fumetti de L’isola del tesoro, per citare un titolo casuale, significa pensare che il suo scopo non sia altro che ri-raccontare la trama del capolavoro di Stevenson, come se oltre l’intreccio non ci fosse nella letteratura alcunché di significativo. Trascurare, in fase di scrittura quanto in fase di lettura, il dato estetico-formale del testo trasposto implica irridere quello stesso dato estetico-formale che è proprio dell’opera di partenza e che è invece l’aspetto che più di ogni altro dovrebbe interessarci quando parliamo di lettura, l’unico che non andrebbe sminuito. Quale importanza diamo alla lingua, alla forma, se tutto ciò cui prestiamo attenzione è se quell’adattamento mette in fila gli eventi nell’ordine giusto senza curarci del modo in cui lo fa? Trascurando la forma che veicola, supporta e rende letteratura quegli eventi nel nuovo linguaggio?
Per citare un caso positivo, Il rapporto di Brodeck, adattamento a cura di Manu Larcenet del quasi omonimo romanzo di Philippe Claudel, è un buon fumetto perché il lettore può addirittura giudicarne la bontà senza aver letto il libro cui è ispirato, libero dall’onere di pesarne la fedeltà alla trama. È un buon fumetto per il suo valore formale, per la capacità di raccontare usando quei meccanismi che solo il fumetto possiede, e nel farlo dimostra un’attenzione che trascende il mero concatenarsi della narrazione ma che anzi si concretizza proprio nella riflessione su come rendere e trasporre la forma, più che la trama, in un linguaggio altro.
Ed è per questo che nelle sua peculiare non-visualizzabilità, leggere Lovecraft tradotto in immagini e riflettere su quanto dello stile e delle idee dell’autore vi rimane e quanto ne viene invece spurgato attraverso quel processo di (ri)creazione che chiamiamo appunto adattamento, è occasione privilegiata per interrogarsi su tutta la filiera: l’opera prima (in senso cronologico); l’atto traduzione linguistica e talvolta crossmediale; l’opera seconda.

L’esterno e il familiare: Il colore venuto dallo spazio
Nel saggio The Weird and the Eerie – lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo (Minimum Fax, 2018, traduzione di Vincenzo Perna), Mark Fisher afferma che “qualunque dibattito sulla Weird Fiction deve partire da Lovecraft” (p. 18). In questo senso – ma anche per il nostro scopo di esplorare l’opera nei suoi adattamenti – mi sembra particolarmente interessante addentrarci nella questione lovecraftiana prendendo come punto di partenza il racconto del 1927 intitolato Il colore venuto dallo spazio: se ne possono trovare diverse versioni a fumetti ma soprattutto ci fornisce un esempio cristallino della struttura e dell’animo profondamente weird (di buona parte) dei racconti dell’autore.
La storia si apre con un narratore senza nome che racconta direttamente al lettore del suo viaggio di lavoro attraverso le colline a occidente di Arkham, cittadina immaginaria del New England, segnate da una inspiegabile calamità di cui la “landa folgorata” – zona di terra cinerea ormai corrotta e senza vita, nella quale l’erba non cresce e il vento non soffia – è imperitura cicatrice.
L’incipit del racconto, la crescente angoscia e l’imbattersi del narratore con la “landa folgorata” sono un piccolo capolavoro di efficacia immaginifica: il lettore non sa ancora cosa sia accaduto in quei luoghi, quale tragedia li abbia fatti marcire, eppure ne avverte la portata destabilizzante. Dopo una prima ricognizione della zona devastata, il narratore torna versa Arkham al calar della sera e ammette: “Avrei desiderato che ci fosse qualche nuvola, perché nella mia anima s’era insinuato uno strano timore dei grandi cieli vuoti sopra di me”. E, poco più avanti, ribadisce: “Il bacino [idrico] verrà costruito tra poco, e i vecchi segreti della regione saranno al sicuro sotto molti metri cubi d’acqua; ma anche quando ciò sarà avvenuto non credo che mi piacerà visitare la zona di notte. Almeno, non quando risplende il cielo stellato”. Una dichiarazione di resa, di un timore sottile ma impossibile da mettere a tacere per il vasto cosmo inscrutabile e i suoi misteri che talvolta irrompono perniciosi fino a qui.
È Ammi Pierce, un superstite di quei “giorni terribili” dei quali la landa folgorata è traccia evidente, a raccontare all’io-narrante cosa sia effettivamente accaduto, per quanto difficile a credersi. Il narratore non farà poi che da intermediario verso il lettore. Questa è già una caratteristica interessante delle storie di Lovecraft: raramente leggiamo il racconto di fatti nel loro compiersi, è anzi quasi sempre ben presente la dimensione della testimonianza (diretta o indiretta) o addirittura del racconto della testimonianza. Così, ne Il colore venuto dallo spazio, non scopriamo del meteorite caduto – assieme al suo indescrivibile abitante – nella fattoria dei Gardner dal punto di vista di Nahum Gardner in persona, che più di tutti ha pagato il prezzo di questa sventura: questo darebbe ai fatti una certa aura di oggettività, pur nella loro finzione letteraria. Il racconto ci viene anzi trasmesso come leggenda, o perfino come mito, dalla rielaborazione di un narratore tutt’altro che onnisciente che ne è venuto a conoscenza dalle parole di un testimone, che a sua volta non era che un osservatore, una figura vicina ma laterale agli eventi. Il dubbio sulla credibilità delle fonti non è extradiegetico, ma parte della poetica stessa. Il narratore lo conferma: “non chiedetemi quale sia la mia opinione [sul racconto di Ammi]: non lo so e questo è tutto”. A volte non sapere è meglio, ovvero, parafrasando Schrödinger, è la curiosità a uccidere il gatto.
Scopriamo così, se al racconto del racconto decidiamo di credere, che qualche anno prima dell’incontro tra Ammi e il tecnico del bacino idrico è caduto un meteorite nei terreni della fattoria di Nahum Gardner, rilasciano poco alla volta una sorta di veleno per la vita e per la mente. A seguito del ritrovamento, le piante producono frutti marci e poi avvizziscono, le bestie muoiono, l’acqua pare portatrice di strane visioni, le menti cedono fino a determinare la decomposizione violenta dei corpi. Tutta la famiglia Gardner viene travolta da questa follia giunta dallo spazio nella forma di una meteora e del suo abitante: un colore indescrivibile e contagioso, “quasi impossibile a descriversi” e “dotato di proprietà esterne e obbediente a leggi sconosciute”.
Due cose mi paiono particolarmente rilevanti di questo racconto, che si conclude con l’inspiegabile e immotivato ritorno del colore innominabile nello Spazio, ma anche con l’abbandono a terra di un pezzo di sé, con la minaccia di un secondo avvento della calamità. La prima è che in esso c’è tutta l’essenza del weird come descritta da Morton: la capacità cioè di apportare “al familiare qualcosa che normalmente si trova al di fuori di esso, e che non si riconcilia con il ‘casalingo’ (neppure come sua negazione)” (p. 10). È interessante che Lovecraft caratterizzi l’esternalità di questo visitatore venuto dallo Spazio da un lato attribuendo agentività inspiegabile a un colore e cioè a ciò che normalmente non è un agente, e dall’altro descrivendolo attraverso il frequente uso di sinestesie ontologiche. Gli attribuisce infatti caratteristiche afferenti a campi semantici all’apparenza incongrui – “un colore malato e fondamentale” – allo scopo di intensificarne l’aura di esternalità. È una figura retorica centrale in Lovecraft, che restituisce con precisione l’alterità delle entità che irrompono nel familiare in un modo che molti epigoni o emuli mancano di comprendere a fondo e che, sorprendentemente, ritroviamo invece nel primo capitolo del Ti con zero di Calvino, nel quale Qfwfq racconta l’avvento della Luna nell’orbita terrestre. “Prendeva forma, una forma non ben definibile perché gli occhi non s’erano ancora abituati a definirla ma anche perché i contorni non erano abbastanza precisi per delimitare una figura regolare, insomma vidi che diventava una cosa. E mi fece senso”. E ancora: “La vedevo avvicinarsi […] e dilatarsi imponendo su questo nostro paesaggio familiare non solo la sua luce d’un colore sconveniente, ma anche il suo volume, il suo peso, la sua incongrua sostanza” (i corsivi sono miei).
Il secondo aspetto interessante, che segue direttamente dal primo e cioè dal modo in cui questa esternalità si manifesta, è che parrebbe impossibile anche solo ipotizzarne una trasposizione in un linguaggio visivo. D’altro canto, come può essere possibile rappresentare davvero un colore “malato e fondamentale”, diverso da ogni colore terreno? Una possibile risposta ci può essere data da tre adattamenti provenienti da epoche e culture fumettistiche differenti che se all’apparenza aggirano il problema in realtà lo risolvono: Il colore venuto dallo spazio di Gou Tanabe (J-Pop, traduzione di Monica Bollini) e l’omonimo racconto contenuto rispettivamente in Da altrove e altri racconti di Erik Kriek (Eris Edizioni, traduzione di Alexander Tegelaars), Il colore che cadde dal cielo contenuto in I miti di Cthulhu di Alberto Breccia (Comma 22, traduzione di Norberto Buscaglia). Ad accomunare questi tre titoli altrimenti del tutto dissimili c’è che sono in bianco e nero. Scelta non imputabile a semplice cifra stilistica degli autori (per quanto in due dei tre casi l’acromia sia in effetti cifra stilistica), ma risposta ragionata a un dilemma concreto: come rappresentare un colore irrappresentabile?
In questo senso è particolarmente efficace la strada intrapresa da Tanabe, che agli adattamenti lovecraftiani ha dedicato per intero la sua attività di mangaka, che utilizza due diversi tipi di retinatura (elemento tipico del manga classico) a seconda che stia disegnando il mondo che conosciamo o ciò che è alieno: nel primo caso i retini aggiungono ombre e profondità, per esempio ai volti dei personaggi; nel secondo lavorano di sottrazione, risultando in punti luminosi che seguono melliflui pattern geometrici assenti nel resto del fumetto. Tanabe instaura fin da subito un grado di realtà sul quale costruire e mantenere, per contrasto, l’alterità del colore alieno che vediamo attraverso una rappresentazione mai diretta – sarebbe impossibile – ma simbolica.
La risposta emotiva che l’autore intende generare nel lettore, inoltre, passa perlopiù dalle reazioni dei personaggi agli eventi, creando un effetto non dissimile dalla testimonianza tipicamente lovecraftiana. Se infatti il fumetto si presta poco al “racconto del racconto”, struttura che rischierebbe di divenire pesante e di poggiarsi eccessivamente su didascalie e voci fuori campo sconnesse alle immagini, questa dimensione di distacco tra il lettore e i fatti viene qui mantenuta attraverso le espressioni dei protagonisti di fronte all’innominabile: non ci viene chiesto di reagire in prima persona al colore e ai suoi effetti, quanto semmai di empatizzare con chi quegli effetti li sta subendo. Sono più i loro volti terrorizzati a gettarci nello sconforto.
Analogamente, Kriek rimuove quasi del tutto la figura del narratore e, dopo una breve introduzione affidata in uno slancio di inventiva allo stesso Ammi Pierce invece che allo sventurato addetto al bacino idrico, il racconto prosegue in un lungo flashback narrato al presente. Lo stile cartoon e quasi divertito dell’autore olandese poco si presta alla sottile poetica lovecraftiana dell’esternalità. La scelta è quindi frontale: il colore viene appena menzionato e il raccapriccio deriva dall’accento posto sull’esagerazione carpenteriana delle mutazioni generate dall’infezione più che dal dramma psicologico vissuto dai protagonisti. I corpi venuti in contatto con il l’essere uscito dal meteorite sono contorti in un’esplosione di pustole e tentacoli, generando nel lettore più repulsione che angoscia esistenziale, in linea con il tono più leggero della narrazione. Perfino il finale viene alleggerito, con un burbero ma tutto sommato di buon umore Ammi Pierce che saluta i suoi interlocutori, non particolarmente persuasi dal racconto.
Su Breccia e il suo approccio astratto e impressionista torneremo poi in maggior dettaglio, ma è interessante notare come l’autore argentino ponga immediatamente l’accento sulla piccolezza dell’uomo di fronte ai misteri dell’universo con i quali sta per venire in contatto: nella tavola d’apertura, tutta cielo, si nota minuscolo per confronto un viaggiatore solitario, schiacciato sotto l’inscrutabile oscurità imperante. È la base dell’orrore cosmico, che Breccia come nessun altro saprà mettere in immagini.

Ciò che non si può rappresentare: Il richiamo di Cthulhu
Se Il colore venuto dallo spazio è un ottimo esempio di weird e pertanto efficace introduzione alla poetica e all’estetica di Lovecraft, è altrove che possiamo riscontrare l’insieme di tutti quegli elementi che ne hanno consacrato l’immaginario nello spettro caleidoscopico della cultura popolare. In questo senso credo sia opportuno soffermarci su Il richiamo di Cthulhu che, scritto l’anno precedente, introduce l’iconica semi-divinità blasfema dalla testa tentacolare, manifestazione fisica dell’orrore cosmico che avrebbe reso famosa l’opera dell’autore. E se da un lato questo racconto, letterariamente parlando meno entusiasmante del precedente, ci permetterà di ancorare il weird e l’esternalità a questioni di grande attualità, dall’altro ci consentirà di esplorare altre e più radicali criticità che emergono dal processo di adattamento, visuale ma non solo.
Dopo una breve introduzione la storia si apre, ancora una volta, con una testimonianza indiretta. Il giovane Francis ritrova, tra i carteggi lasciatigli da un prozio recentemente deceduto, menzione di strani avvenimenti: sogni ancestrali che infestano le menti di giovani artisti e poeti, parole di lingue incomprensibili, visioni terribili di città sommerse e di mostruosi guardiani di orrori indescrivibili. La stessa curiosità, che si trasforma in frenesia di conoscenza prima e in ossessione poi, che colpì il prozio e che come ampiamente suggerito ne causò la morte, si impossessa anche di Francis, deciso a svelare il segreto innominabile di Cthulhu. Ha così inizio un’investigazione che coinvolgerà sette segrete e strani e osceni rituali, e il terrore generato da una progressiva consapevolezza: qualcosa si sta risvegliando. Qualcosa di oscuro e antico, che ha atteso pazientemente nelle profondità degli abissi oceanici il momento giusto per il ritorno, qualcosa di talmente alieno e atavico e potente che la mente umana non può che cedere al suo cospetto. Per tornare a Fisher: “Le storie di Lovecraft si concentrano in maniera ossessiva su ciò che sta al di là: un esterno che irrompe per mezzo d’incontri con entità anomale provenienti dal remoto passato, stati alterati di coscienza, bizzarri contorcimenti nella struttura del tempo. L’incontro con l’esterno si conclude spesso con il crollo e la psicosi” (p. 19). Ossessione e psicosi sono parole chiave.
Nonostante il finale risibile – che vede il risvegliato Cthulhu ritirarsi dopo essere stato letteralmente speronato da una barchetta –, il racconto introduce e popolarizza uno dei topoi lovecraftiani per eccellenza: blasfeme divinità aliene note come Grandi Antichi, immani per dimensioni e inconcepibili dalla limitata razionalità umana nella loro alterità totalizzante. Al cospetto di questi esseri abominevoli la scienza è impotente e la mente, pur essendone attratta in un moto di terrore magnetico reminiscente del Sublime burkeano, vacilla.
Cthulhu, essere posto a guardia imperitura della sommersa città di R’lyeh, fin dalla sua prima descrizione “chiama in causa un senso di non-correttezza”. È pertanto l’entità weird per eccellenza: “talmente inusuale da generare la sensazione che non dovrebbe esistere, o perlomeno non dovrebbe essere qui. Eppure, se l’entità oppure l’oggetto è effettivamente qui, allora le categorie utilizzate finora per dare senso al mondo non possono essere valide. La cosa weird non è sbagliata, dopotutto” perché la sua presenza è innegabile, ce l’abbiamo davanti agli occhi. E allora “dovranno per forza essere inadeguate le nostre concezioni” (p. 17). Tutto quello che credevamo di sapere viene frantumato, ciò che credevamo possibile invece esiste e ci guarda negli occhi. Il crollo psicotico è inevitabile.
La prima descrizione dell’abominio è in realtà la descrizione di una sua rappresentazione su una tavoletta d’argilla (di nuovo, non esperienza diretta ma testimonianza di una rielaborazione) sulla quale “troneggiava una figura realizzata con evidente intento figurativo, anche se l’esecuzione impressionista impediva di farsi una chiara idea della sua natura. Sembrava una specie di mostro, o un simbolo che rappresentasse un mostro [corsivo mio], e l’aspetto era quello che solo una fantasia malata potrebbe concepire. Non sarò infedele allo spirito dell’icona se dico che la mia immaginazione, a volte un po’ bizzarra, se la raffigurava contemporaneamente come una piovra, un drago e una caricatura umana. Una testa molle e tentacolosa sormontava un corpo gigantesco, scaglioso, con ali rudimentali; ma era l’aspetto complessivo che lo rendeva orribile”.
.jpg)
Nonostante gli innumerevoli disegni della bestia che affollano il web, e che non mancano di sminuirne la terribile portata immaginifica riducendola a umanoide verdognolo con tentacoli al posto della bocca, è nella non visualizzabilità dell’essere che sta la sua possanza. Fisher dà una buona definizione del processo lovecraftiano che porta alla (non-)delineazione di questi esseri: “Non appena l’autore definisce un’entità come ‘indescrivibile’, inizia a descriverla […]. Ma questa sequenza contiene un terzo momento. Dopo (1) la dichiarazione di indescrivibilità, e (2) la descrizione, ecco sopraggiungere (3) l’invisualizzabilità. Nonostante tutti i dettagli, o forse proprio a causa di questi, le descrizioni di Loveraft non permettono al lettore di condensare la sua logorroica schizofrenia di aggettivi in un’immagine mentale coerente” (pp. 26-27). È uno stratagemma di scrittura semplice ma efficace, che trova un antesignano illustre e notevolissimo per grado di sovrapponibilità nell’Apocalisse di Giovanni: “Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande” (13: 1-2, traduzione C.E.I.).
È una tracotanza di accostamenti incongrui al limite dell’ossimorico, ribadita dal resoconto meno visivo ma più emozionale dell’incontro vis-à-vis con la mostruosa progenie delle stelle: “L’Essere apparve alla vista: viscido e torreggiante, compresse la Sua verde, gelatinosa vastità nell’uscio nero per emergere nell’aria appestata di quella città di follia. […] L’Essere era indescrivibile, non esiste lingua adatta a simili abissi d’immemore e agghiacciante follia, a tali mostruose contraddizioni di tutto ciò che sappiamo di materia, energia e ordine cosmico. Una montagna camminava, o meglio barcollava”. L’essere è al contempo viscido e torreggiante, montagna e gelatina, agghiacciante e barcollante. C’è da chiedersi come, se la non visualizzabilità è il cardine dell’alterità di questi esseri, un simile racconto possa reggere la trasposizione a fumetti.
In questo caso Gou Tanabe, nella sua versione de Il richiamo di Cthulhu (J-Pop, 2019, traduzione di Silvia Ricci), cade piatto. Se il suo stile di disegno “realistico” – termine inteso con l’accezione che si usa per descrivere il disegno tipico del fumetto popolare, dal basso grado di sintesi del tratto e la quasi nulla astrazione – ben si prestava alla rappresentazione dei volti terrorizzati di fronte al colore venuto dallo spazio, e quindi per transitività al far trasparire le proprietà colore stesso, qui l’anelito di verosimiglianza non agevola l’intento terrifico. Il momento topico dell’incontro con “la montagna che barcolla”, in quello che dovrebbe essere il suo aspetto inadatto a essere descritto da alcuna lingua umana, si riduce allo scontro frontale tra una barchetta e un umanoide gigante dalla testa di piovra. Grande e minaccioso, certo, ma non esterno e sostanzialmente indescrivibile quanto dovrebbe e vorrebbe essere.
Ben diverso è invece l’approccio – e il talento, a essere sinceri – di Alberto Breccia che mantiene inalterata la struttura della testimonianza, riducendo al minimo il discorso diretto in favore di un’abbondanza di didascalie diacroniche, e ritarda il più possibile la rappresentazione dell’entità. La stessa tavoletta d’argilla su cui la “incontriamo” la prima volta ci viene mostrata solo nel retro, e ne possiamo intuire il contenuto dalle reazioni che hanno i personaggi nel vederla, in un modo non dissimile dall’approccio di Tanabe al colore venuto dallo spazio. È solo qualche pagina più tardi, nell’incontro reale con Cthulhu, che Breccia esplode le tavole in un tripudio di inchiostro a tratteggiare una figura astratta, impossibile da cogliere nella sua indiscutibile, irrazionale possanza. D’altro canto la pittura astratta esiste ormai da un po’ e Breccia, con talento artistico e consapevolezza fumettistica indiscutibili, se ne appropria per rappresentare l’irrappresentabile, condensando in una manciata di pagine la miglior trasposizione lovecraftiana possibile. Rinuncia a futili tentativi di rendere coerenti descrizioni che non intendono esserlo, e a rimanere inalterati sono di conseguenza il tono e il senso di disagio, e poi di terrore di fronte a immagini di entità che sono per natura inafferrabili, inconciliabili con il familiare nemmeno per negazione, esterne. Weird, appunto.
Una razza irrilevante e transitoria
Leggere al giorno d’oggi Il richiamo di Cthulhu – e Lovecraft in generale – può generare un certo effetto di straniamento che nulla ha a che fare con il weird, con l’incontro/scontro con l’esternalità, con i Grandi Antichi e il loro indescrivibile incombere, ma che deriva invece da un sottotesto razzista che fa capolino qua e là, in maniera nemmeno troppo laterale. Fin dal principio del noto racconto, quando viene ricordata la morte del prozio di Francis, le parole scelte dall’io-narrante in una prima persona che ne avvicina la voce a quella dell’autore, sono infatti le seguenti: “i testimoni sostenevano che fosse caduto all’improvviso dopo che un negro (probabilmente un marinaio) lo aveva urtato uscendo da uno dei bui e strani cortili che si aprono sul fianco scosceso della collina”. Poco più in là è il narratore stesso a commentare i componenti della setta adorante Cthulhu: “Per la maggior parte si trattava di marinai, con una percentuale di negri e mulatti che venivano dalle Indie Occidentali, dalla Brava portoghese e dalle Isole di Capo Verde. Era questo a dare una coloritura vudù a un culto altrimenti eterogeneo”. Si noti come “coloritura vudù” sia più una definizione valoriale che antropologica. In generale non si va troppo per il sottile nell’aleggiare una relazione e forse una causalità razziale tra i fanatici del culto, descritti come ben diversi dalla gente civilizzata. “Ci sono delle qualità vocali che sono tipiche degli uomini e altre delle bestie: è terribile udire le une quando la fonte dovrebbe essere un’altra”, si dice commentando il coro blasfemo composto per lo più da “negri e mulatti”; l’idea che siano subumani è più che suggerita. Perfino nel riportare un articolo di giornale, che oggi si vorrebbe scevro da termini offensivi, l’equipaggio di una nave di cultisti è descritto come “composto da una strana e poco raccomandabile ciurma di Kanaka e sanguemisto”.
Sul razzismo intrinseco nella poetica e nel pensiero personale di Lovecraft si è scritto molto, spesso costruendo teorie elaborate basate su simbolismi e metafore. Ma mi sembra che, come ritengo emerga dai passaggi sopra citati, per trovare del razzismo nelle opere dello scrittore sia sufficiente fermarsi a un livello molto più superficiale: non c’è bisogno di scavare tropo a fondo. In questo senso è particolarmente interessante il saggio di Bruce Lord The Genetics of Horror: Sex and Racism in H.P. Lovecraft’s Fiction, nel quale si afferma non a sproposito che “in una sfortunata maggioranza della fiction lovecraftiana, c’è una focalizzazione predominante su un razzismo semplicistico. Con semplicistico in intendo che il razzismo sposato [dall’autore] non fa uso di metafore né comunica alcunché oltre l’inferiorità delle razze non-bianche”.

Non intendo qui esplorare il dibattito su cosa dovremmo pensare – e come dovremmo di conseguenza agire – di fronte a testi non più allineati a una sensibilità politico-culturale fattasi giustamente (e finalmente) attenta alla diversità e refrattaria alla sua denigrazione. È peraltro un dibattito di cardinale importanza, per quanto spesso macchiato da ambo le parti da posizioni ideologiche dalla relativa profondità critica, che andrebbe quindi approfondito adeguatamente con altri spazi e mezzi. Mi limiterò invece a citare Walter Siti che nell’introduzione a Contro l’impegno scrive, puntualmente, che “ogni lettore reale si trova a confrontarsi con quello implicito ed è più che comprensibile che provi disagio. I suoi parametri culturali sono diversi” (p. 15). È magari non giustificabile ma tutto sommato ragionevole aspettarsi che Lovecraft pensasse, nel 1926, a un lettore implicito ben diverso dal ritratto di chi, oggi, legge i suoi racconti. Tuttavia, se pure in questo contesto possiamo forse affrancarci dal prendere posizione rispetto alla questione generale, la riflessione specifica sul lettore implicito è inevitabile. In particolar modo nel momento in cui si procede all’adattamento: se infatti, come affermavamo in apertura, l’adattamento non è semplice trascrizione ma atto di creazione in sé, l’autore e di conseguenza il lettore reale non possono in alcuna maniera esimersi dal considerare il mutato contesto culturale, politico e sociale.
Non è un caso quindi che negli adattamenti più recenti, tra i testi citati quelli di Tanabe e Kriek, ogni traccia di razzismo e classismo sia stata omessa o del tutto rimossa. Perfino in Breccia, che dipingeva la sua versione dei miti di Cthulhu negli anni Settanta e che in generale si mantiene più fedele ai racconti per struttura e tono, i riferimenti razziali sono depotenziati o lasciati a elemento meno che laterale. Se sposiamo la lettura di Bruce Lord che il razzismo lovecraftiano non sia soltanto il sottoprodotto della sua epoca ma “elemento fondante per interpretarne correttamente la scrittura e la natura dei mondi che attraverso di essa ha creato”, allora c’è da chiedersi se questi adattamenti non tradiscano in certa misura lo spirito – in quest’interpretazione non meno che pernicioso – dell’opera prima. Un tradimento legittimo in quanto ogni opera (trasposizione o no) non ha che da rispondere alla sensibilità del suo autore, ma tradimento cionondimeno.
Se viceversa, come lo stesso Lord ammette poche righe più in là, accettiamo che a lato – o perlomeno al di sotto – della disturbante visione politica dell’autore ci sia dell’altro, allora omettere gli elementi divenuti problematici per far emergere il resto è operazione non solo legittima ma anche rigenerativa, che richiede di riflettere su chi sia il lettore ideale e su chi sarebbe se lo stesso Lovecraft scrivesse quei racconti adesso. Propendo per questa seconda interpretazione perché, se la poetica lovecraftiana è perdurata – e si è anzi fatta molto attuale – al graduale ma generale scivolare del razzismo nell’immoralità, non è certo per via della mera qualità della scrittura: non è un caso, in questo senso, che a entrare nel canone della cultura popolare sia stato più l’immaginario che i racconti stessi che l’hanno generato.
Nella seconda parte della sua carriera, Lovecraft imprime una svolta personale al weird, tingendolo di una tonalità particolarmente angosciosa e inaugurando il sottogenere noto come “horror cosmico”. Per quanto i prodromi di questa nuova via siano rintracciabili già nei primi racconti e più in generale nel weird come filone, è negli scritti più maturi e in particolare in quelli ascrivibili al “Ciclo di Cthulhu” che l’esternalità tipica del genere diventa mezzo per ricontestualizzare l’uomo in quanto specie, per mettere in discussione l’antropocentrismo tutto. Per farsi messaggio filosofico e, razzismo a parte, perfino politico.
L’altrove che irrompe nel familiare non è più solo disturbante, è anche immane, estremo nel suo mettere alla prova la tenuta stessa della mente di chi vi assiste. Prende la forma di esseri antichi al punto da poterli considerare eterni, titanici, imperscrutabili nella loro torreggiante finalità di distruzione. “I Grandi Antichi, liberati, avrebbero insegnato all’uomo nuove bestemmie, nuovi modi di uccidere e di provare piacere, e tutta la terra sarebbe bruciata in un olocausto di estasi e di licenza”. Vengono dallo Spazio insondabile, da zone che come viene ampiamente suggerito la nostra scienza non può nemmeno cominciare a concepire, figuriamoci a spiegare. E non a caso le menti primariamente toccate dal risveglio, dall’avvento o dall’avvicinarsi di queste entità non sono quelle degli scienziati – il cui desiderio di comprensione è limitato dalle facoltà dell’intelletto – ma più spesso quelle di poeti e artisti, più sensibili per natura a ciò che è profondo, inconscio, irrazionale. Persino quando la minaccia esterna è non più di un colore altro, che pure divora e consuma tutto ciò che incontra in attesa di tornarsene nello spazio siderale, gli studiosi della Miskatonic University perdono agilmente interesse per il fenomeno che accettano in fretta come oltre la loro comprensione. Nulla più. Della zolla di terra toccata dal meteorite durante i giorni terribili, l’io-narrante de Il colore venuto dallo spazio afferma che “i racconti popolari l’hanno soprannominata ‘landa folgorata’. I racconti popolari sono strani, e lo sarebbero ancora di più se gli uomini di città e i chimici dell’università li prendessero abbastanza sul serio da analizzare l’acqua del pozzo”. Poi, alla vista della landa stessa il narratore si ricrede sulla natura bizzarra di quel nome così teatrale, e afferma: “Nessun altro nome avrebbe potuto adeguarsi a un simile paesaggio, e nessun paesaggio avrebbe meglio meritato quel nome. Era come se un poeta avesse coniato la frase dopo aver visitato quella particolare regione”. La poesia, e più in generale l’arte, come sensibilità privilegiata di fronte a ciò che la scienza non può (o peggio ancora rinuncia a) comprendere.
Viceversa, nello stesso racconto, si suggerisce più volte che la salvezza di Ammi Pierce di fronte al fato della famiglia Gardner siano stati il suo intelletto e istruzione limitati: “Era una fortuna che Ammi non avesse più che tanta fantasia; anche così la sua mente mostrava segni di cedimento, ma se fosse stato in grado di riflettere e collegare tra loro i portenti che lo circondavano, sarebbe impazzito completamente”. Da ciò che la scienza accantona perché incapace di capire, e da ciò che poeti e artisti percepiscono e intuiscono come vastità di terrore, solo l’ignoranza ci può salvare. L’incipit de Il richiamo di Cthulhu rincara la dose e recita: “Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l’incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo in una placida isola d’ignoranza in mezzo a neri mari d’infinito e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze […] non ci hanno arrecato molto danno: ma la ricomposizione del quadro d’insieme ci aprirà, un giorno, visioni così terrificanti della realtà e del posto che occupiamo in essa, che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di una nuova età oscura”.
È qui che, ritengo, stanno la forza e l’attualità dell’immaginario lovecraftiano e dell’horror cosmico che ne è scaturito generando numerosi epigoni – con livelli di qualità e lucidità altalenanti. In una lettera indirizzata nel 1927 all’editore di “Werid Tales”, la rivista in cui pubblicava i suoi scritti, Lovecraft scriveva: “Tutti i miei racconti si fondano sulla premessa fondamentale che leggi, interessi ed emozioni umane comuni non abbiano alcuna validità e significato generale nell’universo. […] Per conquistare l’essenza dell’autentica esternalità, sia essa riferita a tempo, spazio o dimensione, è necessario dimenticare che elementi come la vita organica, il bene e il male, l’amore e l’odio e altri attributi limitati di una razza irrilevante e transitoria chiamata umanità abbiano qualunque tipo di esistenza”. Una razza irrilevante e transitoria, piccolissima di fronte ai misteri del cosmo vasto e indifferente, pronta a scomparire. L’incontro con l’esterno, l’irrompere dell’altrove, non ha che questa funzione: permettere all’uomo di cogliere, pur di sfuggita, questa terribile verità e impazzire o immobilizzarsi pietrificato. Nessuna salvezza è possibile dopo la rivelazione. D’altro canto, per quanto Cthulhu sia tornato al suo silente riposo, “i suoi ministri danzano ancora su questa terra” mentre una parte del colore innominabile riposa ancora in ciò che era stato il pozzo dei Gardner. Una volta che il là ha travalicato le sue barriere ed è entrato nel qua non c’è possibilità di ritornare nella nostra placida isola di ignoranza.
In tempi recenti e recentissimi l’umanità, quella vera, ha dovuto confrontarsi con entità analoghe: difficili da comprendere, perfino alle volte da immaginare, eppure portatrici di effetti tangibili e irreversibili e pertanto simili per natura all’esternalità lovecraftiana. La catastrofe climatica della quale riconosciamo i primi segni ma che fatichiamo ad accettare, l’insorgere di nuove e terribili malattie, il consolidarsi dei pericoli della rete che tutto tocca, la lenta ma inevitabile ascesa delle intelligenze artificiali. Entità che non vengono dallo Spazio profondo – alcune sono perfino di fattura umana – eppure più simili ai Grandi Antichi di quanto ci piacerebbe ammettere: minacciano la nostra esistenza per come la conosciamo e ci costringono a ricontestualizzare il nostro status, generando al loro sorgere lo stesso livello di fanatismo o di negligenza intellettuale che riconosciamo nei cultisti di Cthulu da un lato e negli studiosi della Miskatonic University dall’altro. Ci ricordano le qualità proprie della nostra razza che quando viste attraverso la lente dell’horror cosmico paiono così ovvie: irrilevanza e transitorietà.
È forse per questo che trovo gli adattamenti a fumetti di questi racconti di particolare interesse. Non solo perché danno nuova vita a un immaginario complesso e puntuale, mettendone in duscussione al tempo le posizioni anacronistiche da un punto divista politico, quanto perché c’è qualcosa nel tentativo di rendere visibile il non visualizzabile che ricorda il tentativo di comprendere l’incomprensibile che siamo, con sempre maggior urgenza, chiamati a intraprendere. Nelle orribili mutazioni di Kriek, negli sguardi terrorizzati di Tanabe e nelle masse informi e astratte di Breccia possiamo rivedere noi stessi che cerchiamo di far fronte al nostro futuro, di categorizzarlo, di renderlo concreto.