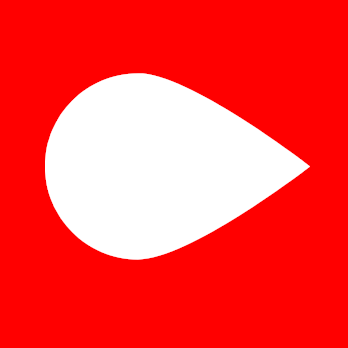Venezia 78. Passato, presente e futuro
A pochi giorni dalla fine della settantottesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ripercorriamo i film presentati al Lido, cartina di tornasole sullo stato dell’arte del cinema contemporaneo.
C’è una scena in Spencer, ultimo film di Pablo Larraín dedicato alla figura di Lady D, dove Diana spiega ai figli che, pur esistendo tre tempi (passato, presente e futuro), dentro quelle mura (quelle della residenza reale di Sandringham, dove il film è ambientato) ne possono esistere solo due (passato e presente) che si interscambiano diventando una cosa sola e immutabile. Questo momento chiave del film racchiude bene le primissime impressioni scaturite nel vedere la selezione ufficiale della settantottesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dalla quale il cinema è uscito vivo, vivace, in grande forma, ma forse non così nuovo, rinnovato. O almeno, anche quando ha cercato di essere nuovo, lo ha fatto guardando al passato, tematizzandolo come atto per riscrivere un presente che possa farsi, solo successivamente, futuro.
Innanzitutto è stata un’edizione di veterani, iniziata con Pedro Almodóvar e proseguita subito con Paul Schrader, Jane Campion e Mario Martone. Autori che hanno ripercorso il loro lavoro, aggiungendo tasselli al grande mosaico della loro filmografia, imponendo variazioni, più o meno grandi, ai propri temi. Un’edizione di sguardi al passato, al Novecento e ai suoi rimossi, tra guerre, condizioni sociali e parabole di grandi personalità della Storia.
Il passato come ossessione e trauma da disseppellire
Nel già citato Spencer di Pablo Larraín, il passato è una condizione di stallo. L’utilizzo che il regista fa del personaggio di Lady D è quello di una figura anticonformista bloccata tra le mura di un palazzo reale dove l’antico si fonde col presente, dove la tradizione è istituzione, dove tutti, non solo i reali ma anche la servitù (veri personaggi comprimari del film), rispettano le regole, sistematizzandole, emarginando la donna immergendola in una condizione di crisi personale e isteria che diventa atto politico (per chi ricorda Ema, il bellissimo film precedente del regista). Un gesto, questo, infantile tanto quanto concettuale, di una donna (ce ne sono state tante in questo festival) che rifiuta il destino da reale, lo rigetta come ogni cosa che mangia, preferendo tendere a un punto-futuro che però non trova mai, se non nei suoi figli. La ricerca ombelicale di Diana è bloccata in quel limbo tra la fuga da un passato-tradizione (un destino da rifiutare), la caduta in un passato-maledizione (il fantasma di Anna Bolena che la perseguita come simbolo della sua sorte) e la ricerca di un passato-redenzione (la casa vicina alla residenza che è pretesto per ripercorrere la sua infanzia e la sua provenienza). Per il resto, tutto tende alla morte, all’assenza di futuro.

Dunque il passato è qualcosa da disseppellire per rielaborare il presente e riappacificarci con la Storia, come succede letteralmente in Madres paralelas di Pedro Almodóvar, dove una madre (Penélope Cruz, Coppa Volpi alla miglior interpretazione femminile) trascina con sé il peso di un trauma collettivo, tramandato dalle donne della sua famiglia, riguardante la morte del nonno sepolto all’inizio della guerra in una fossa comune insieme ad altri uomini dello stesso villaggio. Uno spettro, un capitolo da chiudere, con cui riappacificarsi, disseppellendolo e dedicandogli il giusto rituale. Nel frattempo il passato è anche desiderio, fascino vintage, come per la protagonista dell’horror-thriller psicologico a tinte pop di Edgar Wright Last Night in Soho, storia di una giovane studentessa di moda appassionata di anni Sessanta che, dopo essersi trasferita a Londra, riesce misteriosamente a catapultarsi in quell’epoca, incontrando una diva di successo, dietro la quale però si celano misteri e orrori che, per l’appunto, sarà proprio la ragazza a disseppellire nel presente. Il passato come immaginario affascinante, ma deviante, che nasconde delle ombre cancellate solo superficialmente dalla Storia. Infine uno dei film più compiuti del festival, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Gran premio della giuria), in cui il regista si allontana dagli sfarzi degli ultimi lavori e si dedica a raccontare un capitolo della propria vita, ovvero (non è uno spoiler, ma un fatto risaputo) la morte dei propri genitori; realizzando un’opera più contenuta che passa dal tenero, per quanto comico e grottesco, ritratto di famiglia, all’introspettivo e rarefatto dramma individuale. Un film dal dolore trattenuto, dove ripercorrere l’evento sembra un atto sensibile come toccare una ferita ancora aperta. Sorrentino ci si avvicina piano, leggermente, ma senza avere nessuna paura di farlo. Il passato è un trauma, un’autobiografia, da affrontare nel momento giusto, con delicatezza; qualcosa che a volte, quando fa male, si finge ancora di non guardare.
Il passato, però, è anche un “rimosso” che torna a galla e che, in questa mostra, sembra assumere più di tutti le forme della tortura. Come quelle avvenute a inizio millennio nella prigione di Abu Ghraib in Iraq da parte dell'Esercito degli Stati Uniti, di cui il protagonista de Il collezionista di carte di Paul Schrader (in questi giorni al cinema) è colpevolmente responsabile, ma ne ha scontato la pena in passato, e mentre prosegue la sua vita dai toni “monastici” e come sempre anti-americani, giocando d’azzardo, arriva l’occasione di vendicarsi di un “istruttore-capo-mandante” che ai tempi ne uscì pulito. La tortura è anche quella del caso di Grzegorz Przemyk, uno studente picchiato a morte dalla milizia nella Polonia degli anni Ottanta, raccontata dal regista Jan P. Matuszynski nel film Leave no Traces, che rimette in scena – affidandosi a tempi dilatati, durate importanti (160’) e uno stile asciutto al servizio della narrazione – la storia dell’unico testimone e amico che rincorre la giustizia incappando in continui occultamenti da parte dello Stato.

Non sottrarsi allo sguardo
La tortura come “rimosso” sociale della storia recente è anche la chiave di lettura attraverso cui si può leggere il Leone d’oro di quest’anno: L’Événement di Audrey Diwan. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Annie Ernaux, il film ripercorre l’odissea di una giovane studentessa nella Francia degli anni Sessanta che dopo aver scoperto di essere incinta deve decidere se rinunciare agli studi o affidarsi a un aborto, a quell’epoca illegale. Rischiando la prigione, tanto quanto l’ostilità della propria famiglia, la protagonista si affida a vie clandestine, offrendosi a un sacrificio e una violenza al pari della tortura e, come tale, esplicitamente imposta da una società responsabile. La regista Audrey Diwan pedina con macchina a mano, come il cinema europeo fa da decenni, ma nei momenti più complicati decide di non affidarsi a dei fuori campo, assumendosi la responsabilità di mostrare la violenza, mettendo gli spettatori di fronte al dolore e al sangue che non hanno voluto, o che non hanno fatto loro vedere per troppo tempo.

Proprio attraverso questo atto del mostrare che obbliga lo spettatore di fronte a qualcosa da cui non può sottrarsi, giocano altri due film presentati in concorso alla Mostra, quelli che più sono riusciti a rimettere in discussione il medium, sperimentando sguardi non convenzionali e nuovi modi di mettersi in relazione con il pubblico. Entrambi agiscono platealmente sullo sguardo, esplorando radicalmente i suoi limiti di oggettività e realtà, affidandosi a ritmi contemplativi e a un montaggio e una scrittura ridotti all’osso. Da una parte Reflection di Valentyn Vasjanovyč, ambientato nella Guerra del Donbass, storia di un chirurgo ucraino catturato dalle forze armate russe, tenuto prigioniero e obbligato, come d’altronde lo stesso regista obbliga lo spettatore, ad assistere alle torture (anche qui ritornano). Un percorso interiore tra un prima e un dopo la cattura, tra una buia prigione e un luminoso appartamento piccolo borghese, che blocca lo spettatore di fronte a inquadrature fisse, inerme davanti a una visione univoca, formale e violenta. Dall’altra parte, invece, Il buco di Michelangelo Frammartino (Premio speciale della giuria) che rimette in scena la storica vicenda di un gruppo di giovani speleologi che nell’Italia degli anni Sessanta raggiunsero, per la prima volta, il fondo dell’abisso del Bifurto, una delle grotte più profonde d’Europa nell’entroterra calabrese. Anche Frammartino cerca un rapporto non convenzionale con lo spettatore, ma lo fa nel chiamarlo a muoversi nell’inquadratura, nell’utilizzo di ritmi naturali, nella contemplatività, nella ricerca di un’immagine incontaminata, nello sguardo interrogativo verso la natura.

Invece, i già citati Larraín e Sorrentino lavorano all’opposto con il non mostrato, l’occultato. Nella stanza di Diana, per esempio la tenda deve essere chiusa, cucita, bisogna celarsi dallo sguardo dei giornalisti; o, altrettanto, in È stata la mano di Dio il protagonista si alterna tra ciò che può e non può vedere (il cinema tra tutti è sempre occultato, si pensi a Fellini come al VHS di C’era una volta in America). Così fanno i fratelli D’Innocenzo nel loro America Latina – storia della perfetta vita di un dentista che crolla inspiegabilmente nell’abisso – lavorando su ciò che si vede e non, sull’ambiguità del reale e della distorta visione soggettiva. Nuovi sguardi che aprono a nuove strade, pur dando idea di andare “a braccio”, sperimentando. Quello dei due fratelli sembra un cinema empirico, in continua ricerca di qualcosa, come oggi è bene che il cinema faccia.
L’industria tra Usa e Italia
Tornando alla questione temporale, solo due sono gli espliciti tentativi di tematizzare il futuro e, paradossalmente, sono anche gli unici due film ad avere due personaggi in grado di vedere letteralmente in avanti nel tempo. Uno è Dune, primo capitolo della nuova trasposizione cinematografica del romanzo fantascientifico di Frank Herbert firmata da Denis Villeneuve (in questi giorni nelle sale italiane), l’altro è Freaks Out, nuovo film di Gabriele Mainetti che torna alla regia sei anni dopo il sorprendente successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Sono due titoli che guardano avanti da un punto di vista esclusivamente industriale, per ambizione, per investimento, per scommessa. Sono due anelli di due grandi processi commerciali, due grandi budget, due progetti mastodontici e rischiosi.
C’è, però, un distinguo importante da fare. Il film di Villeneuve sembra ricalcare le formule del kolossal cinematografico americano degli ultimi decenni, della narrazione segmentata e divisa in capitoli, della saga alla Warner Bros.. Così, proprio nel suo progetto sulla carta già pienamente sondato dall’industria hollywoodiana e alla luce del precedente flop al botteghino dell’accoppiata Villeneuve-Warner (vedi Blade Runner 2049), anche se riesce a interpretare la storia in chiave contemporanea (guardando, non sempre consapevolmente, alla politica internazionale attuale),sembra comunque dire poco di nuovo (oltre a rischiare un secondo flop, di cui ci si augura il contrario, perché Villeneuve è un grande regista e potrebbe veramente dare dignità a un progetto a cui non è bastato questo primo passo per avere giustizia).

Invece il film di Mainetti sembra proprio riuscire a portare di nuovo il cinecomic a Roma, ma questa volta alzando l’asticella su tutto (forse troppo, ma non importa), firmando una fiaba fantasy, piena di effetti speciali ed eccentriche trovate visive, ambientata durante la seconda guerra mondiale, con quattro freaks fenomeni da circo con superpoteri e un pianista nazista che può vedere il futuro e che si mette sulle loro tracce. Mainetti ci riesce perché pur emulando quello che in parte è un film “molto prodotto” come Dune, lo fa in un territorio incontaminato come l’Italia, dove una spinta per rianimare la filiera (soprattutto quella del cinema lontano dagli “autori” o dalle commedie) è attesa da anni, in un mondo non saturo e che forse oggi non ha ancora del tutto bisogno di guardare ad altro. E se l’antagonista, come qualcuno non ha mancato di notare, è un alter ego del regista (nel suo strafare eccessivo, nel suo essere un ponte con il nostro presente e quindi l’unico a conoscere il procedere degli eventi), chissà che anche Mainetti non abbia visto il futuro… almeno quello produttivo, di mercato, dell’industria cinematografica italiana, che da questo festival è uscita in stato di grazia.