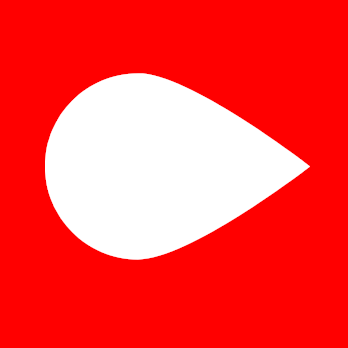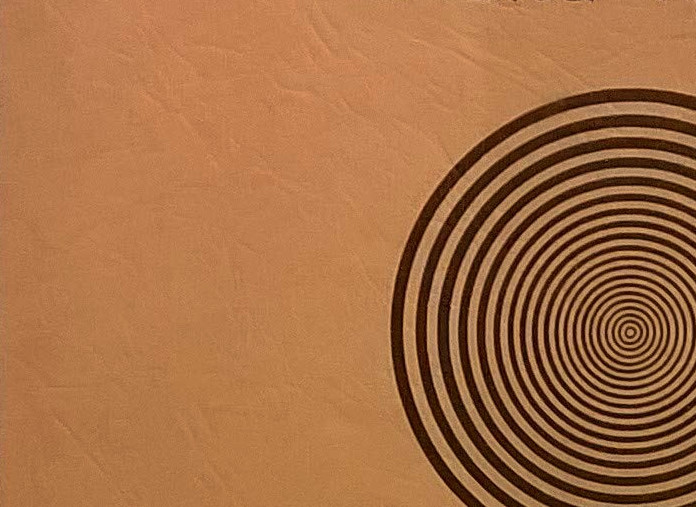
E tornare sempre all'origine
Uno scambio con il curatore e traduttore di "Advaita Vedānta - Una ricostruzione filosofica" di Eliot Deutsch, di recente pubblicazione per Tlon.
Esiste una piccola collana – “minore”, si potrebbe dire – nel catalogo delle edizioni Tlon, che tuttavia credo abbia un valore divulgativo molto importante. Si chiama «Radici» ed è composta da esili libelli che introducono argomenti di altissima complessità: L’insegnamento di G. I. Gurdjieff e le sue origini di Alessandro Boella e Antonella Galli, I tarocchi e la tradizione iniziatica di Daniele Palmieri, How to accelerate. Introduzione all’accelerazionismo di Tiziano Cancelli, e da qualche mese possiamo trovarvi anche Advaita Vedānta. Una ricostruzione filosofica di Eliot Deutsch.
Perché penso abbia un grande valore questa collana di libri brevi su argomenti giganteschi? Poiché si cerca, in questi libri, tramite le parole di rinomati esperti, che si mettono totalmente al servizio del lettore, di restituire, per quanto possibile, una costellazione di idee e insegnamenti in grado di arricchire e di fornire una prima chiave di lettura funzionale rispetto a una sorta di “filosofia perenne” che si nasconde proprio – forse – nei sistemi di pensiero più insoliti e distanti dal nostro.
La pubblicazione più recente, Advaita Vedānta. Una ricostruzione filosofica di Eliot Deutsch, l’unica finora in traduzione, è stata – rispettando lo spirito della collana – curata e tradotta da Adriano Ercolani, un intellettuale che si è sempre occupato di filosofie orientali, meditazione, ma anche di Dante, Blake, di graphic novel, della Lazio, di politica, di Carmelo Bene, eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe fare una lista infinita dei suoi ambiti di studio, che vanno dalla tradizione vedica, al trash nostrano più popolare.
Ho deciso quindi di intervistarlo, un po’ per presentare il libro e un po’ per capire insieme il suo punto di vista su cosa questo testo rappresenta e ha rappresentato, e il perché della sua importanza, la ragione ultima della sua pubblicazione: e della nostra lettura.
Andrea Cafarella - Eliot Deutsch è conosciuto come uno dei padri della cosiddetta filosofia comparata. Mi verrebbe pure da dire che oggi questo concetto – della “filosofia comparata” – dovrebbe essere stato ampiamente sorpassato, e dovremmo forse considerare lo studio della filosofia solo nei termini della filosofia comparata. Mi rendo conto, tuttavia, che per quanto la situazione, anche accademica, sia molto diversa dal contesto vigente nella prima metà del Novecento, c’è sicuramente ancora bisogno di questa etichetta, purtroppo. Questo libro lo dimostra chiaramente.
Essendo tu stesso uno studioso eclettico, che tende costantemente a comparare, a trarre idee dall’est e dall’ovest – così come dal basso e dall’alto – ti chiedo: in che modo mantenere il tipo di sguardo che presuppone la filosofia comparata può servire a pensare e, in qualche maniera, a osservare i fenomeni nel loro variegato complesso?
Adriano Ercolani - Credo che sia essenzialmente l'unico sguardo possibile, attualmente, almeno a livello accademico, su questi temi. Ciò che Max Weber, e gli storicisti in genere, non possono comprendere è che non si può imprigionare in una griglia di contingenze una sapienza perenne. Lo sguardo di molti studiosi razionalisti su questi ambiti di conoscenza è simile a quello di coloro che, in un celebre aforisma di Nietzsche, consideravano pazzi coloro che ballavano perché non riuscivano ad ascoltare la musica. O, per rimanere in termini aforistici nietzscheani, sono quelli che vedono piccoli coloro che si innalzano perché non riescono a volare.
Come dici giustamente, un approccio comparativo dovrebbe essere finalmente sorpassato, ma nell’epoca presente l’eccesso di informazioni e di, cattiva, comunicazione ha innalzato barriere individuali invece di abbattere muri collettivi. C’è ancora bisogno, per parafrasare liberamente un verso di Blake da cui ebbi l’impudenza di trarre il titolo di un mio vecchio blog, di «spezzare le manette della mente». Come insegna l’Advaita Vedānta, per comprendere qualcosa bisogna diventare quel qualcosa.
Che, per l’Advaita Vedānta, è contemporeaneamente la sola cosa che esiste e tutto ciò che esiste, ovvero la Realtà suprema, che si rivela al di là delle illusioni mentali.
Diciamo che prima di cominciare questo percorso di conoscenza la logica lineare aristotelica va relegata nel cassetto delle utilità pratiche.

AC - Torniamo però al libro in questione: Advaita Vedānta. Una ricostruzione filosofica. Proviamo a dare, brevemente, al lettore non ancora informato, l’idea di cosa sia questo «sistema filosofico» indiano, dalle radici antichissime, e quali sono i pilastri fondamentali sui quali si erge?
AE - Deutsch lo spiega con chiarezza: «È stato, e continua a essere, il sistema di pensiero più accreditato tra i filosofi indiani ed è, a nostro giudizio, una delle più grandi conquiste della ricerca filosofica, tra quelle riscontrabili sia in Oriente che in Occidente. Allo stesso tempo l’Advaita Vedānta è più di un sistema filosofico, almeno nel senso che diamo a questa espressione nell’Occidente contemporaneo: è anche una guida pratica all’esperienza spirituale, ed è intimamente connesso ad essa». E soprattutto sintetizza perfettamente: «L’Advaita Vedānta è tanto una religione quanto un sistema filosofico; è sia un percorso di realizzazione spirituale che un sistema di pensiero». Per l’Advaita, fondamentalmente, la conoscenza coincide con la realizzazione dell’unità, della non-dualità (ovvero il significato di “advaita”) dell’esistente, dissolvendo la distinzione tra soggetto e oggetto, su cui ancora la filosofia occidentale testardamente s’incaponisce, nella suprema identità del Brahman. Nelle parole di Deutsch «l’esperienza della pienezza atemporale dell’essere», che è sia «uno stato silente dell’essere» che «un dinamico divenire».
AC - Mi colpisce come nell’introduzione l’autore, Eliot Deutsch, tenda quasi a giustificarsi, sottolineando il rigore filosofico dell’Advaita Vedānta: «il fatto che il Vedānta si interessi alla realizzazione spirituale non ne sminuisce il valore filosofico». Perché, secondo te, c’è sempre stato questo scarto tra Oriente e Occidente, basato sull’idea che il pensiero delle culture, soprattutto dell’Asia sud orientale, fosse limitato all’ambito religioso e quindi privo di una dignità filosofica e metafisica?
AE - Fa benissimo Deutsch a chiarire quel punto. Dagli anni ‘60 in poi la divulgazione indiscriminata della filosofia orientale operata dai falsi guru (maestri solo nelle tecniche di marketing ma cialtroni dal punto di vista spirituale) ha stretto una santa alleanza col pregiudizio spocchioso delle accademie eurocentriche: tutto ciò che profumava di Oriente era automaticamente uno sciocco passatempo superstizioso per fricchettoni. Così i falsi guru si sono tenuti la loro fetta di mercato di ricercatori ingenui da spennare e le accademie occidentali hanno potuto continuare a vellicare il proprio ego in sterili elucubrazioni, sempre più arbitrariamente dogmatiche e progressivamente sganciate dalla realtà. Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia, lo ha spiegato in un libro di qualche anno fa: L’altra India.
Schematizzando brutalmente, Sen spiega che l’apparente attaccamento al pensiero magico e a forme di devozione tradizionale che appaiono superstiziose a un disincantato occhio scientista, non sono tuttora fondative della cultura indiana perché «non hanno mai avuto l’Illuminismo»… Ma perché ce l’hanno avuto molto prima di noi. La sua tesi è che esista una tradizione razionalista e scettica alla base della civiltà indiana ed è questa ad aver creato il terreno per la proverbiale tolleranza culturale che nei secoli scorsi ne è stata la luminosa caratteristica distintiva: la possibilità di pacifica convivenza religiosa in un paese grande come un continente.
Durante il regno, diremmo noi rinascimentale, dell’imperatore Akbar convivevano musulmani e induisti, giainisti, zoroastriani e perfino cristiani. Poco dopo la Chiesa Cattolica dava fuoco a Giordano Bruno. Seimila anni prima, almeno a ciò che si racconta, i dibattiti alla corte di Re Janaka non avevano nulla da invidiare per sottigliezza teologica alle discussioni della nostra Scolastica (ce n'è una sublime testimonianza nell'Asthavakra Samhita, scritto circa venti secoli prima del nostro Rinascimento). In Occidente, al contrario, da Voltaire in poi chiunque creda in un dio, o recuperi il senso del sacro o parli di spiritualità è considerato filosoficamente un cretino: peccato che anche Voltaire si professasse teista, e non ateo. Del resto, ipse dixit: ha scritto il Trattato sulla Tolleranza (e anche però tante pagine traboccanti antisemitismo). Si è sostituito un principe del principio d’autorità con un altro.
Questa derisione della dimensione religiosa e spirituale però non ha abbattuto i dogmi o debellato i fanatismi, gli ha semplicemente applicati altrove, creando eserciti di credenti nel nulla, illusi di essere “liberati” e razionali. Ne vediamo la conferma desolante sui social ogni giorno: il relativismo assoluto, il “pensiero debole”, non ha creato una tolleranza fondata sull’umile consapevolezza dei propri limiti gnoseologici, al contrario ha aperto le gabbie dell’opinionismo sfrenato. Lo trovo veramente ridicolo: persone che credono ciecamente in sistemi di pensiero che sostengono che ogni opinione è relativa e fallace... tranne la loro. Questo fa sì che sulle pagine dei quotidiani si riversino gli odi freddi di menti chiuse che vomitano idiozie diffamatorie su un genio sommo come Dante Alighieri, ad esempio. Questa è la perfetta manifestazione del Kali Yuga, l'Età della Confusione. Dopo la morte di Dio non si è assistito all’avvento dell’Oltreuomo (almeno, finora), ma a quello di tanti “umani, troppo umani” convinti di essere loro stessi il dio in cui non credono più.
In questi casi, verrebbe voglia di mettere delle casse da rave sul Monte Athos e sparare a palla il finale del primo scherzo telefonico a Mario Magnotta.

AC - Sarebbe una bellissima scena paradossale, da ammirare in preghiera! Ma proviamo a evitarla facendo un po’ di chiarezza su quali sono le differenze ontologiche e radicali tra l’Advaita Vedānta e i sistemi filosofici occidentali più conosciuti; e come, conoscere queste disuguaglianze, potrebbe arricchire vicendevolmente i due modi di pensare e di concepire l’esistenza?
AE - C’è una frase di Shankara che ricorda una battuta di Kierkegaard contro i filosofi idealisti: il sommo teologo indiano dice che per guarire da una malattia è necessario assumere una medicina, non basta proferire la parola «medicina»; Kierkegaard diceva che gli idealisti scambiavano le etichette nelle vetrine dei negozi per gli oggetti che indicavano. Non a caso, Raimon Panikkar li ha accostati in un bel saggio edito da Jaca Book, in cui confronta la fede e l’etica nel cristianesimo e nell’induismo.
Nell’introdurre l’accostamento, Panikkar chiarisce subito le differenze e illumina le affinità; le due culture, occidentale e indiana, sono diverse ma complementari: «La cultura occidentale è caratterizzata dal principio di non contraddizione, quella indiana dal principio di unità». E più in là nel saggio amplifica lo scontro fra le concezioni: «L’Individuo è per l’Occidente un dato di fatto, una constatazione che non ha bisogno di prove, né spiegazioni. Questo dato così evidente nella filosofia occidentale appare invece in India del tutto problematico: è anzi il problema centrale di tutta la tradizione vedantica, che ha in Shankara il suo massimo esponente. Essa cerca di stabilire che cosa sia questo io, in modo che possa servire come punto di partenza per qualsiasi speculazione». Ananda Coomaraswamy, ne La tenebra divina, offre uno sguardo vertiginoso sui rapporti tra Shankara e Platone, e su tutta la tradizione neoplatonica e gnostica che ne deriva, che del resto lo anticipa di dodici secoli.
Superficialmente, le dottrine possono sembrare antitetiche, una fondata sul dissolvimento nell’Uno, l’altra sulla separazione dal Trascendente. Ricordo sempre però che i dialoghi platonici svolgevano un ruolo essoterico. Un aspetto spesso ignorato: un dettagliuccio, via! Ha solo condizionato il modo di pensare e vivere dell’Occidente negli ultimi 2.400 anni. Il punto, còlto in maniera precisa da Coomaraswamy, è il seguente: «Le filosofie moderne sono sistemi chiusi, che impiegano il metodo dialettico e danno per stabilito che gli opposti possono solo escludersi a vicenda. Nella filosofia moderna, le cose sono o non sono così; nella filosofia eterna, questo dipende dalla nostra prospettiva. La metafisica non è un sistema, ma una dottrina coerente; non è interessata meramente all’esperienza condizionata e quantitativa, ma alla possibilità universale».
Personalmente, oltre le più immediate vicinanze con autori mistici quali Meister Eckhart, sottolineate da Coomaraswamy e di cui si è occupato diffusamente Marco Vannini, ho sempre accostato il sistema Advaita al pensiero di Spinoza.
Una divergenza, secondo alcuni studiosi più verbale che sostanziale, è che il dio spinoziano è concepito razionalmente in termini epistemologici, mentre per Shankara è affrontato in termini ontologici all’interno dell’ortodossia induista, da lui riformata e stabilita attraverso un’imponente opera filologica di commento dei testi sacri.
Se mi consenti un’autocitazione, pertinente, sul confronto tra le due visioni filosofiche: esce in questi giorni per la casa editrice Stamperia del Valentino un volume, Cielo interiore e guarigione. I corpi sottili tra Oriente e Occidente, che ho avuto il piacere di firmare con Alessandro Orlandi e Stefano Riccesi, non solo due intellettuali che stimo ma due grandi amici. Grazie a due shakti “galeotte”, in senso dantesco, cioè Flavia Salomone e Georgia Ferrara (creatrice di Numinosa), questo trio negli ultimi anni si è consolidato in una ricerca condivisa quanto differenziata. Alessandro, fondatore della casa editrice La Lepre e creatore benemerito dell’ex museo romano dedicato ad Athanasius Kircher, è in grado di conciliare in sé lo sguardo di un docente di materie scientifiche con l’apertura mentale di un ricercatore esoterico, dunque da par suo espone nel libro una dotta «storia del corpo sottile» nelle diverse culture tradizionali; Stefano affronta il tema di cui è riconosciuto esperto, ovvero l’ambito che “vive” e divulga con la sua associazione Artemìa: la medicina spagyrica alla luce degli insegnamenti di Paracelso e in generale della sapienza alchemica rinascimentale; io, per non sfigurare davanti a loro, mi sono limitato a sottolineare la grandezza della più classica Trimurti del pensiero indiano: la Bhagavad Gita, Patañjali e Adi Shankaracharya.
Insomma, sempre all’Advaita Vedānta si ritorna.
AC - I concetti che vengono esplicati all’interno del libro sono davvero tanti, esposti tramite un linguaggio molto specifico e rigoroso, che richiede uno sforzo da parte del lettore – ampiamente ripagato. E purtroppo non avremmo lo spazio in questa conversazione per affrontarli tutti (rimando il lettore a questo articolo che riassume bene i punti focali del testo). Ho deciso quindi che ti chiederò arbitrariamente di alcuni passaggi che mi hanno colpito, proprio in una prospettiva comparatista. Il primo riguarda il karma, forse la parola orientale più conosciuta in Occidente. Viene affrontata nel libro considerando le sue enormi contraddizioni interne, è descritta come una «finzione utile». Cosa è quindi davvero il karma e in che senso possiamo “utilizzarlo”?
AE - Nella Brhadaranyaka Upanisad è spiegato: «Nel modo in cui uno agisce, nel modo in cui uno si comporta, così egli diviene. Colui che fa del bene diventa buono. Colui che fa del male diventa maligno. Si diventa virtuosi con un’azione virtuosa, cattivi con una cattiva azione. Grossolano e fine, molteplice, L’incarnato sceglie le forme secondo le proprie qualità».
Io mi riferisco sempre a Deutsch non solo perché stiamo parlando del suo libro ma proprio perché ha il dono di trovare le parole più adatte per far comprendere a una mente occidentale questi complessi concetti, solo apparentemente, così distanti: «Secondo la dottrina del karma, ognuno – in quanto jīva (NdC: sé individuale) schiavo del mondo – è condizionato e determinato dalla propria condotta, così come viene messa in atto in un periodo di innumerevoli nascite, morti, e rinascite. Ogni atto che si compie ha il suo effetto nel mondo e forma in colui che agisce una saṁskāra o vāsanā(tendenza) che diventa la base per le sue azioni future. Karma è quindi una “legge” che stabilisce la relazione che si instaura tra la propria azione come jīva e il proprio stato d’essere». Giustamente, anche Deutsch evoca Platone, nella fattispecie la Repubblica e il Fedone, dacché la metempsicosi è un concetto presente nella sapienza greca da Pitagora in poi, e diverrà cruciale per il Neoplatonismo. Quindi, non dovrebbe essere così strano da comprendere per noi occidentali. Il più grande poema della civiltà cristiana, fondativo della letteratura italiana, si fonda sul concetto di contrappasso. Dante lo mostra con il suo mirabile nitore espressivo, ma già Tommaso D’Aquino ne aveva parlato e, prima ancora, Seneca, in un’opera di cui certo non sarebbe dovuto andare fiero, cioè la satira post-mortem dell’imperatore Claudio.
Mi si obietterà che in quel caso si parla di punizioni in un regno ultraterreno e non di effetti immediati delle proprie azioni in questa (o altre) vite. Beh, Schopenhauer, che l’induismo lo conosceva bene, ha sancito: «Il mondo stesso è il Giudizio Universale».
Sul concetto di “finzione utile”: personalmente, ho sempre pensato che la “legge del karma” fosse l’unica risposta al problema della teodicea, l’unica giustificazione metafisica del Male nel mondo. Ma magari sono sempre stato un po’ strano io.

AC - Un altro degli aspetti che mi interessa di più, come ben sai, è la pratica: la meditazione. Possiamo provare a spiegare cosa intendiamo con questa parola, e magari dare dei riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire questo interessante e fondamentale aspetto dell’Advaita Vedānta e di molte delle filosofie orientali?
AE - Qui si potrebbe scrivere un altro libro, più lungo di quello di Deutsch. Personalmente, la meditazione è il fondamento della mia weltanschauung da circa venti anni. Non la pratica di una determinata disciplina, ma lo sguardo rinnovato che l’esperienza meditativa ti rivela.
Però per “meditazione” in Occidente si intende tutto e nulla: ponderare gravemente qualcosa è “meditazione”, visualizzare i chakra è “meditazione”, contemplare un muro bianco o direzionare i propri pensieri su emozioni passate o scenari ipotetici, andare nelle vite precedenti o semplicemente tenere una posizione statica. Sotto la definizione di “meditazione” attualmente viene contrabbandato di tutto.
Per me la meditazione è uno stato di quiete interiore, di consapevolezza senza pensieri, in cui la mente è immersa in un silenzio colmo di grazia, un silenzio che in realtà è una sinfonia. Ma, appunto, qualsiasi esperienza ineffabile quando viene tradotta nei limiti del linguaggio appare vaga, sfuggente, inconsistente.
Affidiamoci dunque a chi ha provato a superarli tali limiti: consiglio dal punto di vista tecnico-storico il classico LoYoga. Immortalità e libertà di Mircea Eliade (si possono discutere le sue idee politiche ma non la sua statura di studioso), dal punto di vista filosofico-spirituale Chi sono io? di Ramana Maharshi, grande esponente dell’Advaita Vedānta nel Novecento, e per le menti occidentali affamate di prove e ragionamenti Il silenzio mentale di Ramesh Manocha, che spiega benissimo i benefici medico-scientifici dell’esperienza meditativa.
AC - Deutsch scrive che l’Advaita Vedānta è un sistema filosofico creato per «stabilire l’unicità della realtà e condurre l’essere umano alla sua realizzazione». Trovo che proprio questa sia una delle differenze cruciali tra filosofia occidentale e orientale, più in generale. Cosa significa realizzarsi? Ma soprattutto: pensi che all’interno delle società occidentali, per un individuo qualsiasi, sia davvero possibile aspirare a tanto? Sussistono ancora le condizioni per le quali un essere umano nel XXI secolo, cittadino di uno dei paesi cosiddetti industrializzati, possa raggiungere la realizzazione e la conoscenza suprema del suo autentico Sé?
AE - Per me assolutamente sì. Ci sono tutte le condizioni. “Realizzarsi” in termini advaitici non significa certo trovare conferme in successi esteriori ma, scomponendo concettualmente l’espressione, “realizzare” il proprio Sé: con un gioco di parole, ancora più evidente nell’espressione inglese “Self-Realization” diventata proverbiale nella koinè New Age, si intende sia “rendersi conto” di essere il Sé, sia diventare, “rendere reale” il Sé. Ma cos’è il Sé?
Eh, la risposta a questa domanda è di fatto la risposta a ogni domanda, basti consultare le conversazioni di Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj con i loro discepoli di tutto il mondo. O meglio, la risposta a questa domanda è il cuore della riflessione advaitica. Deutsch scrive: «L’Ātman è coscienza pura, indifferenziata e splendente in sé. È un potere supremo di consapevolezza, trascendente rispetto alla coscienza sensoriale ordinaria, consapevole solo dell’Unità dell’essere. L’Ātman è quello stato dell’essere umano cosciente in cui le divisioni di soggetto e oggetto, che caratterizzano la coscienza ordinaria, sono superate. Niente può condizionare questo stato di coscienza trascendentale: tra coloro che l’hanno realizzato non possono sorgere dubbi al riguardo. L’Ātman è quindi vuoto di qualsiasi differenziazione, ma per l’Advaita non è un semplice vuoto: è l’infinita ricchezza dell’essere spirituale».
Si tratta quindi di un’esperienza che mette in contatto con l’Assoluto, o meglio fa scoprire che l’Assoluto è dentro di noi, o meglio che noi siamo già l’Assoluto... Vedi? La New Age ha talmente consunto il linguaggio spirituale che qualsiasi affermazione mistica sembra detta da Corrado Guzzanti (grande advaitin laico!) mentre parla di Quelo (tra parentesi gioco di parole coltissimo col concetto di Tat Twam Asi). Come diceva Shankara, alla fine tutte le discussioni teologiche davanti allo splendore indifferenziato del Sé sono shabda jalam, “ragnatela di parole”. E io penso sempre a Tommaso d’Aquino che interrompe la Summa Theologiae proclamando che davanti alla visione dello splendore divino nella sua mente “percossa da un fulgore”, direbbe Dante, tutto ciò che ha scritto non è che paglia.
Quindi, tornando all'inizio, con buona pace degli storicisti e dei materialisti storici, l’esperienza mistica, in quanto sovrastorica, dovrebbe essere ovunque medesima, come testimoniano i simili accenti di Nicola Cusano, Al-Hallaj, S. Giovanni della Croce e i maestri zen, e via proseguendo per conciliazione di apparenti opposti. Però, per onestà, dobbiamo ricordare che proprio colui che fece del Mysterium Coniunctionis la chiave della sua ricerca, colui che ha portato la conoscenza archetipica e lo sguardo sovrastorico al massimo nitore nel Novecento, cioè il caro Jung, ebbene, proprio lui nella Psicologia del Kundalini Yoga, forse la più affascinante presentazione del sistema sottile dello yoga a un pubblico non orientale, è notorio che avverta sui limiti dello sguardo “psicologico” occidentale su tali esperienze. Ciò spesso viene interpretato come un invito a non “praticare” le discipline orientali, perché tanto non riusciremmo a immergerci completamente nell’esperienza con piena consapevolezza. Non credo sia esattamente così. L’esperienza dell’assoluto non è un condizionamento culturale, né cambia col clima o con i vestiti che uno indossa. Non possiamo essere così superficiali, in nome di Dio!
Anche perché questa, profonda, considerazione di Jung viene talvolta banalizzata per supportare l’ennesimo clichè di moda, ovvero il concetto di “appropriazione culturale”. Intendiamoci, l’appropriazione culturale è un fenomeno esistente, ma, come detto all’inizio, è sciocco applicare lenti storicistiche a un’esperienza che tende all’eterno, all’assoluto, all’atemporale. Tu che, oltre alla mistica, conosci bene l’hip-hop, sai bene come i Public Enemy abbiano attaccato in Fight the Power la figura di Elvis Presley (anche se dopo ammetteranno di aver esagerato) come quella di un razzista addirittura accostato a John Wayne; Eminem, col suo meraviglioso spirito provocatorio, rivendicherà giocosamente il suo ruolo di erede: «I am the worst thing since Elvis Presley/To do black music so selfishly/And used it to get myself wealthy». Nel caso di Elvis posso capire che si parli di “appropriazione culturale”: un bianco prende la musica nera, se ne appropria, la “rivende” e diventa un mito per i bianchi, mentre i neri in quel momento ancora non hanno diritti civili. Capisco la rivolta identitaria. Ma applicare queste lenti a un’esperienza che ti conduce, almeno teoricamente, in uno stato dove le identità non esistono più... è semplicemente idiota. Invece di dissolvere le identità, ci si auto ghettizza in etichette mentali e artificiali, pretendendo di giudicare culture millenarie ed esperienze universali con slogan inventati venti minuti fa in qualche accademia americana. Non si può considerare la tensione verso l’eterno come un fenomeno transitorio. Quando riusciremo a farlo capire ai nostri amati compagni che lottano per un mondo migliore, allora, forse, davvero vivremo in un mondo migliore.
Pensiero
(1979) si occupa da oltre vent'anni dei rapporti tra cultura occidentale e orientale, esplorandone le diverse manifestazioni artistiche. Tra i fondatori deI movimento internazionale Inner Peace, collabora al progetto filosofico Tlon e pubblica regolarmente interventi e approfondimenti su numerose testate (tra cui Linus, Blog del Fatto Quotidiano, minima& moralia).
14-09-2021
14-09-2021