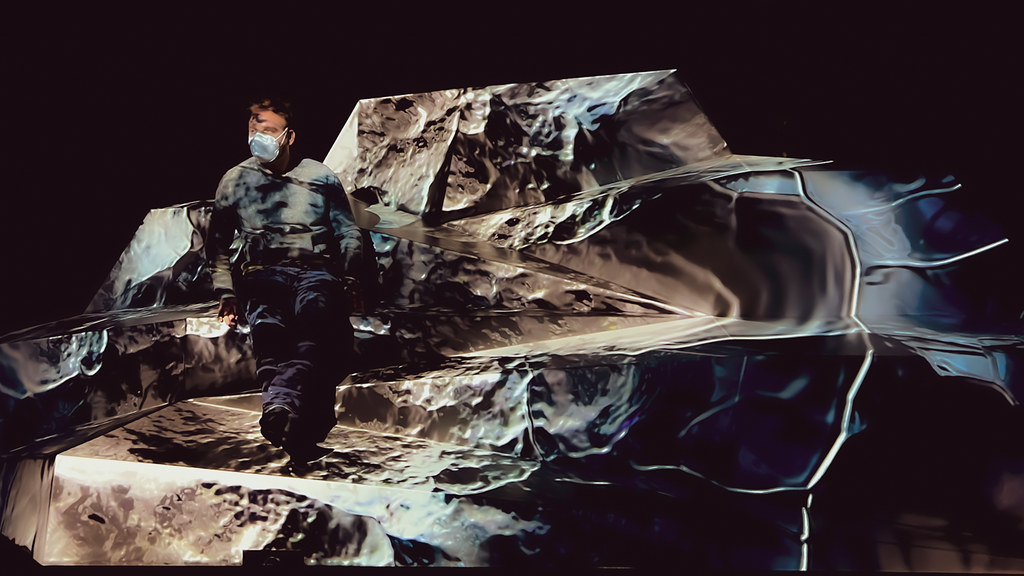Because, if it’s not love, then it’s the bomb that will bring us together
Siamo l’unica specie vivente, insieme alle formiche, che organizza le guerre. Proprio le guerre ci hanno reso, in gran parte, umani come siamo, e proprio dalle guerre traiamo la creatività distruttiva che ci permette di evolvere culturalmente come specie. Questa tesi scandalosa, ma sapientemente articolata e dimostrata, è al centro del saggio “La scimmia armata” dello studioso Peter Turchin (classe 1957), pubblicato di recente da UTET Libri nella traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe.
Cosa vuol dire “creatività distruttiva”? La specie umana avanza ed evolve culturalmente attraverso la grande spinta della cooperazione. Nel corso della nostra vicenda lunga decine di migliaia di anni, quella che inizialmente era una cooperazione di natura tribale fra persone che si conoscevano direttamente, si è trasformata in una rete di cooperazione innanzitutto fra sconosciuti. Una grande opera attraverso la quale di volta in volta abbandoniamo ciò che non ci serve più o si rivela un ostacolo, e abbracciamo nuove soluzioni che ci aiutano ad andare avanti. Nelle società complesse, dobbiamo la nostra sopravvivenza in gran parte al lavoro degli estranei, e nel nostro lavoro quotidiano serviamo in gran parte le esigenze di estranei. Che sia un lavoro di servizio al pubblico allo sportello, o scrivere per lettori di cui non conosciamo il nome, o produrre cibo o altri prodotti che finiranno dall’altra parte del mondo, l’attività umana – con l’eccezione di quelle attività di cura domestica e di prossimità che sono svolte in gran parte dalle donne – è volta a favorire l’esistenza di estranei, ovvero a contribuire al funzionamento di società complesse e di dimensioni enormi, secondo quella che Turchin definisce “ultrasocialità”.
Biologo evolutivo di origine russa, insegnante all’Università del Connecticut, ha costruito insieme a un gruppo di ricerca multidisciplinare uno strumento di analisi storica basato sui dati. La sua visione è ambiziosa: aspira a individuare i modelli, oltre le vicende, che permettono di tracciare i percorsi evolutivi della specie umana dal punto di vista culturale. Ovvero come abbiano fatto, nelle società umane, ad affermarsi e poi scomparire o cambiare tutta una serie di tratti culturali. Proprio la sua ricerca sui dati gli ha permesso di formulare la tesi al centro di questo suo lavoro: che sia stata la guerra, in qualità di espressione massima della competitività naturalmente umana, a favorire la cooperazione all’interno dei gruppi. Quella umana, ricorda Turchin, è l’unica specie – sempre insieme alle formiche – che abbia creato società dalle dimensioni così enormi, e che pratichi la guerra, intesa come “violenza organizzata di gruppo contro altri gruppi”. All’evocazione del cantante degli Smiths Morrissey citata in esergo a questo pezzo, Turchin risponderebbe perciò che è stata di sicuro la bomba, e non l’amore, a unirci. E prima della bomba, tutte le armi che l’hanno preceduta e che hanno segnato, nel corso dei millenni, un percorso evolutivo non lineare, ma sicuramente condizionato dalla capacità offensiva raggiunta e dall’incorporazione della guerra nella vita sociale. Un’incorporazione che è avvenuta in due modi: sia integrando la presenza endemica della guerra e dell’organizzazione militare (con le sue gerarchie) all’interno della società, sia provocando una spinta costante a spingere il più lontano possibile la violenza dai confini del villaggio, incrementando fortemente la convivenza pacifica interna e aumentando fino all’estremo la gittata della violenza bellica all’esterno. Al punto che oggi siamo capaci di sterminare altri gruppi umani a migliaia di chilometri di distanza, senza che la popolazione del Paese aggressore se ne accorga neanche.
Attorno alla capacità offensiva delle armi si articola una costante esigenza delle comunità umane: gestire l’ineliminabile problema della violenza. Prima di Turchin anche altre studiose con approcci diversi, come Barbara Ehrenreich o l’antropologa marxista Evelyn Reed, hanno individuato tale necessità, forse anche con maggiore precisione rispetto al biologo. Fin dalle origini della specie il problema della violenza si è palesato come un problema provocato dai maschi, e lo stesso studioso russo lo riconosce nel suo libro. Sono i maschi quella parte di specie che manifesta la più spiccata competitività aggressiva; ma gestirla e impedire che provocasse danni irreparabili è stato un compito assunto molto spesso dalle femmine, giacché fin dall’inizio della vita umana hanno dovuto capire come far sì che l’aggressività e la tendenza alla competizione non mettessero in pericolo la vita dei piccoli e delle donne all’interno del villaggio.
Le armi furono la loro soluzione geniale. Secondo Turchin, gittata e mobilità prima di tutto servirono, nelle società più antiche, per consolidare la posizione degli esseri umani come una specie capace non solo di difendersi dai predatori ma all’occorrenza di attaccarli, cacciando anche esemplari di grandi dimensioni attraverso le pietre, le frecce e i dardi. Ma servirono anche a stabilire criteri di egualitarismo nelle comunità, in due modi principali: rendendo sostanzialmente di poco conto le differenze di forza fisica fra i sessi, giacché le donne arciere erano abili tanto quanto i colleghi maschi, e non possedevano deficit di sorta nei loro confronti; ma anche permettendo al gruppo, tramite la violenza collettiva, di scoraggiare il bullismo e la pretesa di qualcuno di assumere il comando. Non di rado i prepotenti venivano affrontati con la violenza del gruppo, che magari li scacciava a pietrate dal villaggio.
La capacità di violenza che aumentò la forza di caccia degli esseri umani produsse, secondo Reed ed Ehrenreich, un altro effetto: permise alle donne di allontanare il più possibile gli uomini dal villaggio, con il fondamentale scopo di proteggere i più piccoli. In epoche in cui la specie non aveva ancora smesso di praticare il cannibalismo, la guerra fu quell’invenzione – per Ehrenreich, con molta probabilità, un’invenzione femminile – che spinse il raggio della violenza lontano dal perimetro del villaggio, incoraggiandone invece l’uso verso altri gruppi, di animali o di umani estranei. È una considerazione di grande interesse, perché spiega in un certo senso la guerra come invenzione difensiva e a tendenza esogena, a contrasto della violenza endogena. Le ricerche di Turchin a loro volta vanno in questo senso: la cooperazione sociale contrasta la violenza endogena, che se eccessiva, farebbe fallire la società, ma può allo stesso tempo rendere i gruppi umani più aggressivi e violenti all’esterno, favorendo la vittoria su altri gruppi e quindi il successo del proprio.
Nel suo lavoro Turchin si rifiuta in modo abbastanza visibile, ancorché non esplicitamente motivato, di aggregare una prospettiva di genere alle ricerche e alle conclusioni che propone, tuttavia i suoi modelli rappresentano una conferma di numerose indagini e ricerche antropologiche e archeologiche legate alla prospettiva di genere. In particolare, quando spiega il ruolo imprescindibile dei cavalli e del carro come tecnologia che permise ai popoli delle steppe eurasiatiche la conquista di enormi proporzioni di territorio in Europa, conferma quella che l’archeologa lituana Marija Gimbutas definì “l’ipotesi Kurgan”, ovvero che una parte importante della vittoria del sistema organizzativo patriarcale sulle società precedenti, dette dell’Europa Antica, fu dovuta all’invasione violenta di popoli di pastori nomadi provenienti dalle steppe dell’Eurasia, e particolarmente dall’odierna Ucraina. Grazie alla tecnologia del cavallo, questi guerrieri possedevano un vantaggio insormontabile sulle popolazioni conquistate, e poterono così conquistarle e annetterle facilmente.
L’ipotesi Kurgan di Gimbutas fu presa inizialmente poco sul serio nella comunità scientifica, a causa della chiara prospettiva di genere con cui era stata formulata. Gimbutas andava alla ricerca in modo esplicito di quel momento della storia in cui a una cultura generalmente ginofila si sostituì, fino a distruggerne quasi interamente le tracce, una cultura violentemente androcentrica. Le società ginofile erano caratterizzate, in base alle sue ricerche, da una condizione non subordinata delle donne nella società, e da una cultura che si rifaceva al ciclo vita-morte della natura, di ispirazione del tutto diversa rispetto alle successive culture religiose del padre. Nel corso del tempo, prove ed evidenze della fondatezza della sua ipotesi si sono accumulate, da quelle sul DNA a quelle legate alla linguistica. Gli studi di Turchin rappresentano un’ulteriore conferma: fu una civiltà militarmente superiore, capace di utilizzare il cavallo dopo aver imparato ad addomesticarlo e a domarlo, a sbaragliare gruppi che non possedevano questa tecnologia, sebbene fossero a propria volta società complesse, organizzate, prevalentemente agricole. Questa civiltà che riuscì a instaurare il dominio si presentò in foggia di guerrieri quasi tutti uomini, che conquistando i territori ne conquistarono anche le donne, i bambini, resero schiavi gli altri uomini, e instaurarono il proprio regime. Gradualmente, stabilendo una gerarchia militare fissa, costituirono una élite che si autolegittimò tramite una nuova cosmogonia di natura patriarcale.
“Gli arcieri della steppa a cavallo riuscirono a stravolgere stati civilizzati, a sconfiggerne gli eserciti in dettaglio, a distruggerne le città prive di mura difensive. Se non riuscivano a invadere le città murate, potevano ridurle alla fame negando loro l’accesso alla campagna”. Come non pensare alla situazione spaventosa che oggi si vive, in quelle stesse terre, a causa dell’invasione dell’esercito russo in Ucraina che sta adoperando tecniche molto simili a quelle antiche, come la fame intenzionale. Ancora oggi è una questione di tecnologie superiori che vincono e di disponibilità tecnologiche che si sfidano fra loro, ma è anche una questione di cooperazione sociale che è in grado di fare la differenza, su scala locale e globale.
Proprio la cooperazione sociale in tempo di guerra, come dice Turchin, pone il cosiddetto dilemma del cooperatore: prendervi parte come individui è infatti dispendioso per l’individuo, che ne ricaverà benefici collettivi ma che può anche pagare, a volte, prezzi individuali molto alti: combattendo si può morire. Lo studioso russo definisce “agenti razionali” quegli individui che per furbizia e avidità, nel momento in cui la cooperazione richiede un sacrificio individuale per poter superare una crisi, ritengono che la scelta nobile sia invece “disertare”: cioè pensare e agire solo per sé. È abbastanza inevitabile pensare a come un certo settore sociale abbia disertato la cooperazione sociale durante la pandemia da Covid-19, per esempio, rifiutandosi di attuare misure di prevenzione di vario genere; o di come una parte della società civile stia mostrando un atteggiamento riluttante nei confronti della cooperazione sociale italiana ed europea alla resistenza ucraina, pensando che i costi da pagare siano troppo alti e rischiosi. E d’altro canto, proprio la risposta alla pandemia per la quale il mondo intero si è riorganizzato così velocemente negli ultimi due anni dimostra che gli umani hanno ormai raggiunto una certa capacità di cooperare come un’unica, enorme società globale.
Secondo Turchin, la pervicacia di forme di antisocialità che pure permangono è legata fortemente alla fiducia nei confronti della “società degli estranei” nella quale viviamo. Alcune società – Turchin cita esplicitamente l’Italia, usando come riferimento la controversa ricerca di Edward Bansfield sul familismo amorale – prediligono forme di tribalismo, come il nepotismo o il clientelismo, che distruggono l’adesione delle persone all’ultrasocietà e concentrano invece gli sforzi degli individui nella difesa della sola famiglia. La permanenza di dinamiche familiste all’interno delle società complesse rende queste ultime inadeguate a vincere le proprie sfide nei confronti di altre società complesse. Le società attraversate da nepotismo e clientelismo si mostrano meno coese, meno in grado di adoperare quel metodo della “distruzione creativa” che consente di liberarsi di ciò che non funziona più e di adottare nuove pratiche, istituzioni, modi di vivere più adeguati alle sfide da superare. In questo senso, il pensiero va anche alle mille resistenze che le classi dominanti di questo Paese e oltre – una sorta di “ultrafamiglia” per prendere a prestito la terminologia dello studioso – stanno ponendo nei confronti delle aspettative della società civile, affinché le sfide lanciate dalla pandemia e dalla guerra portino a distruggere certe forme organizzative che non funzionano – dal lavoro in ufficio costantemente supervisionato e controllato, fino alle politiche energetiche – e ne vengano invece inaugurate altre. Persino la guerra in Ucraina, in questo senso, diventerà la cartina al tornasole per distinguere fra quelle società che avranno saputo unirsi per avanzare sul terreno della cooperazione, o viceversa quelle che si macereranno nelle divisioni e nelle indecisioni perché non riusciranno a pensare in termini di bene sociale collettivo, ma prediligeranno gli interessi di alcuni gruppi su altri. Per esempio, riguardo all’urgenza di trovare alternative ecosostenibili e pulite alla dipendenza dalle fonti energetiche russe.
L’auspicio di Turchin è che la capacità di cooperazione su scala mondiale riesca infine ad abolire la guerra, attraverso una costante competizione per la migliore opera di creazione distruttiva. “Per abolire le guerre servirebbe una cooperare su una scala vastissima, che coincida con l’umanità intera. Del resto la pace non è semplice assenza di guerra; va gestita in maniera attiva.” Ma i costi individuali della cooperazione sociale sono alti; solo ridistribuendo meglio i benefici all’interno della società si potrà convincere ogni persona che è più conveniente, anche nella propria vita individuale, fare la propria parte e dedicarsi a rendere migliore la vita degli estranei. Quella forma di amicizia sociale che può unirci, come una specie di amore, al posto della guerra.
Hai letto:
La scimmia armata: come la guerra ci ha reso umani
Questo articolo è parte della serie:
Recensioni