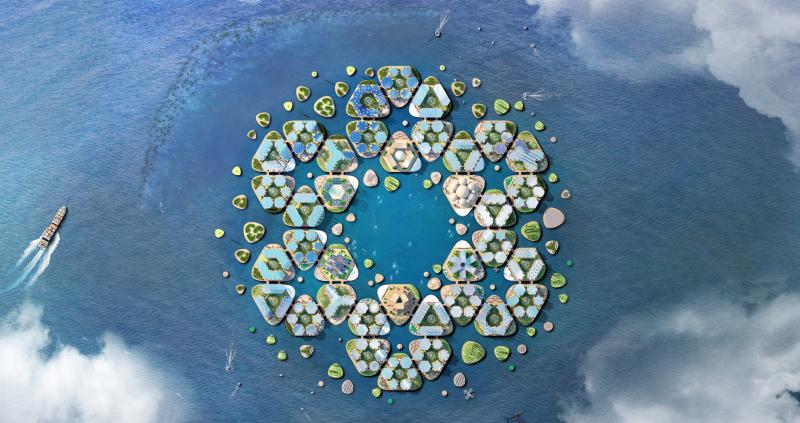Il 99% dei non privilegiati
Progettare con i più poveri tra i poveri: la Barefoot social architecture di Yasmeen Lari.
Yasmeen Lari è un’architetta pakistana la cui attività con "i più poveri tra i poveri" invita a una riflessione su alcune questioni non tanto comode, in particolare una: l’ingiustizia sociale ed ecologica nel mondo, e la risposta inadeguata che il modello assistenzialista occidentale vi sta dando.
Lo scorso 21 ottobre, ottantenne, ha ricevuto presso il Politecnico di Milano la laurea magistrale ad honorem in architettura. In quell’occasione ha tenuto una lectio dal titolo "Humanistic architecture for social and ecological justice", durante la quale, con garbo e una sorta di fiduciosa fermezza, ha sostenuto che: "Gli architetti non dovrebbero progettare solo per l’1% dei privilegiati del mondo". Dovrebbero invece rivolgere lo sguardo e le energie verso le "moltitudini che affrontano un nuovo ordine di crescenti povertà e disparità".
Nel farlo, ha affermato Lari, avrebbero l’opportunità di riscoprire e utilizzare tecnologie costruttive tradizionali, che si rivelano a bassissima emissione di gas serra e rendono possibile avere un impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici.
Ha ricordato anche che non solo le élite hanno diritto a un progetto di qualità, e chiesto di sfuggire alla trappola cognitiva che porta a pensare che "ai poveri vada bene tutto", affermando che dove le risorse sono più limitate, è necessaria più progettazione.
In questa concezione la prevenzione dell’esaurimento delle risorse e la riduzione delle emissioni inquinanti sono consustanziali a un’architettura umanista, attivista, che promuove la dignità e il benessere delle frange più marginali della popolazione e ne valorizza le risorse.
Spesso Lari nei suoi discorsi sollecita le "archistar", le grandi firme dell’architettura su cui troppo spesso la percezione del mestiere sembra appiattirsi, a tenere in considerazione gli svantaggiati del mondo.
Sono le masse più vulnerabili alle diseguaglianze economiche e ai cambiamenti climatici. Sono spesso ignorate dai progettisti, ma – sostiene l’architetta – non possono più esserlo in un mondo globalizzato e in rapido cambiamento.
Lari però suggerisce di non guardare a questi individui da lontano, come a oggetti sfocati di un intervento dall’alto, ma da vicino, come soggetti attivi di co-progettazione, portatori di valori e di un prezioso patrimonio costruttivo tradizionale pieno di potenzialità.
Nella sua visione non è più tempo di megastrutture, prodotto di una mentalità coloniale, ma di un’architettura vernacolare diffusa e consapevole. Che ha come benvenuto effetto secondario quello di essere effettivamente ecologica.

D’altra parte Yasmeen Lari parla a ragion veduta, essendo stata lei stessa una star nella sua professione, e avendo attraversato quasi una sorta di conversione (autodiretta).
Nel 1965, tornata in Pakistan dopo la laurea alla Oxford school of architecture, è stata la prima donna ad aprire uno studio di architettura nel suo paese. Per decenni poi è stata l’interprete di successo delle stesse multinazionali che oggi considera come committenti inaccettabili, alle quali ha fornito una poetica costruita perfettamente adeguata ai loro valori di grandi consumi e piccola considerazione del contesto.
Se si guarda come esempio a una sua realizzazione degli anni ‘90, la Pakistan State Oil House a Karachi, sede della grande compagnia petrolifera, si vedono grandi superfici a vetrate riflettenti, gradoni, simmetria centrale. Tutti ingredienti di una monumentalità che celebra proprio l’arroganza economica e ambientale del petrolio di quell’epoca, e allo stesso tempo la accelera e se ne nutre, richiedendo notevoli sforzi energetici per la climatizzazione e abbondante utilizzo di materiali ad alte emissioni.
L’architetta ha cambiato rotta nell’anno 2000, stufa di accontentare grandi aziende (corrotte), desiderosa di dedicarsi al patrimonio culturale del suo paese, attraverso la fondazione realizzata insieme al marito, lo storico Sunahil Zaheer Lari: la Heritage foundation of Pakistan.
Nel 2005, un terremoto nel nord del paese ha fatto 80.000 vittime, e lasciato senza casa 400.000 persone. Questo ha rappresentato una chiamata per Yasmeen Lari, che si è recata fisicamente nelle zone colpite e ha iniziato il suo lavoro dedicato ai più vulnerabili.
Una fotografia, scattata durante un workshop condotto presso lo Zero carbon cultural centre di Makli, documenta bene questo notevole spostamento di valori e di estetica.
Si vede una donna, il capo coperto da un velo biancorosa, gli avambracci riempiti da lunghe file di bracciali; sta manovrando un trapano, con il quale buca due tronchi di bambù. Alle sue spalle, l’ariosa struttura del centro culturale, che è stato costruito con la medesima tecnologia: si tratta di pannelli composti da tronchi di bambù assemblati perpendicolarmente tra loro con due elementi diagonali di rinforzo, che vengono prefabbricati artigianalmente e poi utilizzati come elementi strutturali. Sono derivati dalla tecnica tradizionale del dhijji e si sono dimostrati capaci di resistere a terremoti molto intensi.
Rispetto a Karachi, anche lo slittamento ambientale è notevole: a Makli siamo in prossimità di una necropoli patrimonio dell’UNESCO, e di comunità molto povere. Il paesaggio è rurale e polveroso, strade sterrate, campi, canali.
Lo Zero carbon cultural centre che qui sorge, completato nel 2017, è una delle più grandi strutture al mondo realizzata completamente in bambù; è un ampio capannone (27x18 metri), coperto con tetto in paglia, dalla sbalorditiva ossatura: ha l’aspetto di un cesto traforato e la resistenza meccanica di un edificio comune.

Con gli stessi pannelli sono stati costruiti nei villaggi della regione Sindh centri per le donne realizzati a palafitta, che si sono resi necessari dalle frequenti inondazioni e si sono rivelati efficaci durante l’evento catastrofico del 2013.
Il bambù è una materia prima facilmente rinnovabile, si coltiva con grande resa e rapidità di crescita, è durevole ed è stato reperito completamente in Pakistan: questi sono i principi con cui negli ultimi vent’anni Lari ha scelto tutti i suoi materiali da costruzione.
Un altro principio l’ha guidata: che gli stessi materiali fossero utilizzabili facilmente, dopo un training opportuno, dalle stesse persone che usufruiranno dei manufatti.
Ecco cosa si fa a Makli nei programmi della Heritage foundation of Pakistan: si impara, con corsi e seminari, a costruire in autonomia e in modo ecologico. Non solo i pannelli, ma mattoni in terra cruda, piastrelle, stufe, intonaci a calce, compost-toilet.
Sono tutte tecniche costruttive recuperate dalla tradizione pakistana e adattate alla massima sicurezza tecnologica, a basse emissioni di gas serra per le proprie caratteristiche intrinseche.
I mattoni in terra cruda, per esempio, antichi quanto l'agricoltura e la città, si degradano facilmente a fine vita, richiedono pochissima energia per la produzione e nessuna emissione di trasporto.
La calce, che si ottiene da roccia calcarea e produce carbonio durante la lavorazione, riassorbe nel corso del ciclo di vita il carbonio immesso nell’atmosfera, ricarbonatandosi nel tempo.
Inoltre le costruzioni realizzate con terra, bambù, calce e tetto di paglia, tendono a essere a basso impatto anche in opera, perché consentono in modo passivo un ottimo isolamento termico e comfort abitativo.
Dopo l’inondazione del 2010 sono stati realizzati 40.000 rifugi sicuri con questi materiali, che rispondono al "Disaster Risk Reduction" (DRR), quindi garantiscono ottime prestazioni meccaniche e vantaggi a lungo termine per le comunità.
Lari ha calcolato che, rispetto agli altri rifugi realizzati nel paese, in cemento e acciaio, con il suo lavoro si sono risparmiate più di 300.000 tonnellate di emissioni, a fronte di manufatti resistenti e sicuri.
Sono piccoli edifici collocati nei pressi dei villaggi, che sono stati realizzati con la partecipazione degli abitanti e con la formazione adeguata a una futura autogestione delle emergenze. Questo permette molta più rapidità rispetto agli interventi condotti dall’esterno, e ha consentito a molte persone in grave difficoltà di recuperare una sorta di normalità in tempi brevi e in modi più vicini al proprio modo di vivere rispetto alle soluzioni prefabbricate con mentalità urbana. Se si danneggiano durante un terremoto sono facili da riparare.
Inoltre un evento catastrofico produce forte malessere psicologico in chi ne è coinvolto, e Lari ha osservato che la partecipazione ai lavori per ristabilire la propria sicurezza allevia questa sofferenza.
Costruire i rifugi a basse emissioni infine evita di contribuire al cambiamento climatico, che è acceleratore dei disastri ecologici stessi, evitando un cortocircuito molto comune quanto paradossale, tipico del modello della carità occidentale, che Lari rifiuta.
Gli individui più colpiti da ingiustizie, disastri e privazioni sono quelli sotto la soglia minima di povertà (Lari calcola che il 30% di coloro che hanno partecipato ai programmi di training l’ha sorpassata entro i dodici mesi successivi), e tra questi in particolare le donne.
Per questo molta formazione è rivolta a loro,come nel caso della costruzione di stufe in terra, le “Chulah rocket stove”.
Lari ha osservato, nelle zone rurali e suburbane, emergere un bisogno prettamente femminile: quello di cucinare in sicurezza, senza essere esposte alle esalazioni dei fuochi liberi.
La tecnologia della rocket stove consiste in un alto camino che, nel tragitto che compie l’aria calda, permette di consumare quasi completamente il combustibile, riducendo al massimo il particolato in uscita e permettendo, quando la temperatura è a regime, di bruciare anche materiali diversi dal legno, come lo sterco di mucca nel caso di quelle pakistane.
Le stufe, secondo il modello tradizionale delle Chulah, sono realizzate in mattoni di terra cruda con intonaco a calce, e hanno così molta inerzia termica; sono situate su piattaforme nello stesso materiale, che offrono uno spazio pulito per preparare i pasti, e proteggono dalle alluvioni. In alcuni casi sono anche magnificamente decorate con motivi naturalistici stilizzati o astratti, diventando delle opere d’arte proprio in virtù delle caratteristiche dei materiali di cui sono fatte.
Per realizzarle sono state formate donne locali, che sono diventate imprenditrici e hanno a loro volta diffuso le conoscenze necessarie all’autocostruzione. Nel 2018 questo progetto ha vinto il premio UN World Habitat.
Tutto questo è ciò che Yasmeen Lari chiama con un sintagma efficace "Barefoot Social Architecture", l’architettura sociale degli scalzi, facendo riferimento al fatto che nei villaggi rurali del Pakistan le persone camminano spesso senza scarpe. Il che è sicuramente un segno poco invidiabile della durezza della vita, ma al contempo può rappresentare la leggerezza con cui chi consuma meno risorse procede sulla terra. "Sono diventati i miei compagni di viaggio", dice Lari, e coinvolgerli nella co-progettazione, utilizzarne le risorse tecniche, non è fare assistenzialismo con logica coloniale, ma massimizzare le loro risorse e il loro ambiente, "l’ecosistema barefoot".
Questo modo di procedere non è relegato alle zone rurali e alle piccole opere, ma si può applicare anche ai centri e agli edifici storici, l’altro patrimonio culturale tangibile di cui la Heritage foundation si occupa.
Nel centro pedonale di Karachi sono state messe in opera piastrelle di terracotta fabbricate da una vicina comunità svantaggiata.
Nello stesso luogo viene ripristinato, con mattoni di argilla e medaglioni decorati, l’edificio della Denso Hall Library, la prima biblioteca costruita nel periodo britannico aperta alla popolazione locale. Una contaminazione, con materiali e tecniche autoctone, di un simbolo poco amato della dominazione straniera.
Yasmeen Lari ha parlato volentieri al Politecnico di Milano, e ha incontrato studenti che hanno lavorato a un modello con i suoi pannelli in bamboo. Lo fa perché spera in un cambio di direzione collettivo per l’architettura: auspica un’architettura che guarisca la terra e – non aiuti – ma dia potere ai più emarginati dell’umanità.