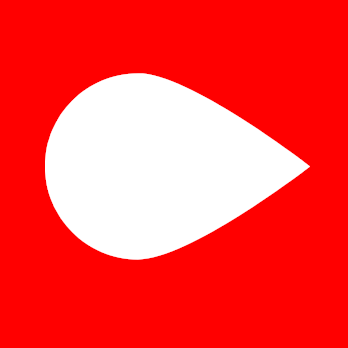L’incredibile Storia
Netflix, Riccione e i circuiti dello storytelling assuefativo.
"Il giorno dell’uscita mi ha chiamato e mi ha chiesto: in una scala da 1 a 10 quanto mi incazzerò? Gli ho risposto: forse molto perché sentirai parlare tante persone che non sopporti, ma ci saranno anche tutte le cose che ci hai detto tu” [1]. È il 30 dicembre 2020, il giorno di uscita su Netflix di SanPa. Luci e tenebre di San Patrignano. Le parole sono quelle di Gianluca Neri, ideatore e showrunner della serie tv. Le inquietudini, invece, sono quelle di Andrea, figlio di Vincenzo Muccioli.
Le regole del gioco sembrano chiare sin dall’inizio: ognuno ha l’opportunità di raccontare la propria versione dei fatti, in una par condicio di luci e ombre. The sins of the Savior è il titolo ossimorico e democristiano per il mercato internazionale.
“In questo mondo la cosa spaventosa è che ognuno ha le sue ragioni” [2]: era il 1939, alla vigilia dell’apocalisse i cui colpi di cannone riecheggiano fuori campo per tutta la durata del film, quando Jean Renoir, nei panni di Octave, ci svelava la règle du jeu. È una cosa spaventosa, certo, che rende la tragedia indistinguibile dalla farsa.
Anche i giorni di fine anno in cui compare SanPa non sono giorni normali. Sono i giorni delle festività negate, giorni di segregazione forzata nelle regioni chiuse e nelle feste solitarie della pandemia. Rinchiusi per il nostro bene, come i ragazzi di Muccioli tenuti alla catena per obbligarli alla disintossicazione; isolati all’interno di “stati di eccezione” [3] in cui vengono temporaneamente sospesi diritti che fino a poco tempo prima credevamo inalienabili; costretti a rispettare rigide norme di profilassi per bloccare la diffusione del contagio come i sieropositivi ai tempi dell’Aids e dell’eroina. Cortocircuiti che risuonano inquietanti in lunghe giornate che sembrano non finire, e che continuano a moltiplicarsi nell’eco delle nostre case. A rendere più sopportabile il peso di queste solitudini ci aiuta Netflix, con la sua droga di stato, pulita e sicura, metadone on demand che ci viene comodamente somministrato a casa. Niente più fredde panchine in squallidi parchi vicino alla stazione.
D’altro canto non si fa nulla - a quanto mi risulta - per nascondere le analogie tra consumo di serie tv e circuiti della dipendenza. Ci sono dei meccanismi entrati a tal punto nella routine degli utenti da rappresentare oramai la modalità standard di fruizione, quali la possibilità di skippare le intro/sigle delle singole puntate o l’automatismo che ci fa saltare immediatamente all’episodio successivo bypassando la lettura dei titoli di coda, in maniera tale da incoraggiare una visione circolare e che promette di essere virtualmente senza fine. Una soppressione transumanista e algoritmica dei tempi morti per prolungare all’infinito il piacere, in una lotta che ha come limite ultimo quello fisico del nostro corpo e della finitezza del nostro tempo.
Come ha affermato con franchezza Reed Hastings, CEO di Netflix: “noi competiamo con il sonno”. Non si parla nemmeno più di binge watching, ma di binge racing, in cui i fan competono tra loro per esaurire la visione della serie in un’unica soluzione, nel giorno stesso in cui viene immessa sul mercato. Pazienza se alla fine di questa overdose di estenuate visioni siamo ridotti a larve con gli occhi sbarrati, che vagano come gli zombie eroinomani che si vedono nei filmati di repertorio all’inizio di SanPa. È una rivoluzione che da tempo ha investito non solo l’architettura di fruizione prevista dalle piattaforme, ma che ha cominciato a operare sempre più in profondità nelle strategie di narrazione e di costruzione drammaturgica dei prodotti, per stare al passo con il capitalismo accelerato della ipermodernità.
Se da un lato, dunque, queste nuove droghe domestiche agiscono come uno stimolante, con tecniche usate per generare nello spettatore un bisogno quasi fisico di non interrompere la visione, dall’altro hanno anche un forte effetto narcotico. Di fronte a una realtà segnata dall’ansia della precarietà e dalla paura del contagio, compromessa da una crisi economica senza precedenti, con l’incubo del riscaldamento globale e la minaccia dell’estinzione di massa [4], la visione ipnotica delle serie tv consente di procrastinare all’infinito il ritorno a una realtà troppo brutta, promette uno stordimento dei sensi in grado di narcotizzare il dolore e sedare le inquietudini. Potente ansiolitico e cura antidepressiva alla portata di tutti.
Forse non è un caso che Netflix abbia individuato nella Romagna la sua terra di elezione e in Rimini, epitome di quella terra che è la mia terra, la fonte mitopoietica e originaria di tutte le storie. Una terra che ha un legame viscerale con la memoria collettiva del Paese, la terra delle vacanze e della giovinezza, dell’estate e delle discoteche. La terra che, oggi più che mai, può incarnare nell’immaginario e nell’inconscio della nazione quella nostalgia dei futuri perduti di cui parla Mark Fisher [5] e che torna a infestare il nostro presente senza speranze con i fantasmi delle visioni dei suoi protagonisti, in un vero e proprio amarcord hauntologico sotto il sole di Riccione [6], tra Fellini e Mussolini.
Vincenzo Muccioli e l’ingegner Giorgio Rosa – star megalomani di SanPa e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose - hanno avuto due magnifiche allucinazioni, la capacità di immaginare futuri alternativi e la forza di costruire comunità indipendenti al di fuori dello Stato. Oggi quelle utopie tornano nelle forme svuotate di narrazioni spettacolari e innocue, in quanto spettrale testimonianza dell’archeologia dei nostri desideri.
Ciò è particolarmente evidente nel caso del film di Sidney Sibilia, che trasforma la vera storia dell’isola al largo di Rimini nell’incredibile storia, in un’operazione che è una metafora folgorante delle strategie di racconto e svuotamento di senso messe in atto da Netflix. Il film, “tratto da una storia vera”, spoglia la vicenda originale degli aspetti più scomodi e delle ambiguità ideologiche, e trasforma quella che per alcuni è stata un inno al libertarismo e una forte dichiarazione politica in una favola per adolescenti che non sanno cos’è il ‘68, una cartolina dalla riviera ‘congelata’ in una permanente summertime [7] dell’anima. L’impresa di Rosa, che nella realtà ha richiesto quasi dieci anni di lavoro e che nel film viene compressa nell’arco di poche settimane, viene degradata a irriverente e stralunato sberleffo di un ragazzo appena laureatosi, che vive ancora con i genitori e insegue una vaga idea di libertà (che coincide più o meno con il “possiamo fare quel cazzo che ci pare”). Il tutto si riduce a una trovata goliardica per fare colpo su di una ragazza, con la benedizione e la “consulenza storica” di Walter Veltroni e la riproposizione caricaturale di quella che già secondo Deleuze [8] è sempre stata una delle qualità genetiche del cinema americano sin dai tempi di Griffith e del suo montaggio alternato, ossia la tendenza a ridurre qualsiasi conflitto, anche le più grandi e complesse trasformazioni storiche e collettive, a un’opposizione di carattere duale, al racconto di una rivalità tra due persone o di una gelosia.

In questa regressione estatica e in questa fuga dalla realtà, la droga che ci viene pompata nelle vene - l’eroina del nostro immaginario - da un po’ di tempo a questa parte ha preso il nome, ubiquo e inarrestabile, di storytelling. Come ha sostenuto di recente Gianluca Didino nel suo Essere senza casa [9], la nostra è “un’epoca di fiction unbound, uno storytelling oramai sfuggito a qualunque controllo e mosso all’infinito e a velocità crescente dalle proprie logiche interne”. In un’epoca in cui le storie - e il modo in cui ci vengono raccontate - hanno il potere di indirizzare le elezioni politiche americane e di cambiare i destini del mondo, non si fatica a comprendere “l’ambizione di Netflix di diventare la grande macchina narrativa del nostro tempo”.
Come è stato notato da più parti - e largamente ammesso dagli autori che lo citano tra le principali fonti di ispirazione - SanPa si modella sull’esempio di Wild Wild Country, la docu-fiction che Netflix ha dedicato con grande successo a un’altra figura di leader carismatico, il guru indiano Osho che negli anni ’80 costruisce dal nulla, nel deserto dell’Oregon, una grande comunità, capace di raccogliere adepti da tutto il mondo, pronti a seguire gli insegnamenti, i precetti e le storie del Savior, tra illuminazioni e omicidi, utopie e attacchi terroristici.
Le affinità tematiche e di contenuto tra le due serie sono a tal punto evidenti e suggestive che rischiano di oscurare le analogie a livello formale: più che di fonte di ispirazione sarebbe corretto parlare, io credo, di adesione a un vero e proprio format. SanPa ne ricalca codici e metodi di lavoro, sotto la supervisione della piattaforma che si preoccupa di confezionare un prodotto rigorosamente glocal, adattando il contesto italiano a una platea internazionale. In quanto format, è un modello che si può applicare con lo stesso successo e le stesse finalità a qualsiasi storia: Luci e tenebre del Terzo Reich, The sins of Madre Teresa… tanto per dare qualche idea.
Assecondando la propensione verso il crime di Wil Wild Country, anche in SanPa la fiction prende decisamente il sopravvento sul documentario, orientando tempi e scelte formali, sia di regia che di montaggio. “Beh, non lo definirei proprio un documentario. È pura e semplice fiction. Cerca l’effetto pulp creando più ombre possibili intorno alla figura del protagonista. Ci riesce benissimo, ma ne falsifica il modello, il pensiero e la storia”: queste le parole di Andrea Muccioli dopo aver visto la serie. Anche a uno sguardo superficiale, infatti, non può sfuggire l’andamento finzionale di SanPa, con la sua suddivisione in capitoli – Nascita, Crescita, Fama, Declino, Caduta – che ricorda i cinque atti del teatro classico e al contempo rimanda ai precetti descritti da un manuale di sceneggiatura all’americana o alle tappe di un qualsiasi viaggio dell’eroe [10].

Perché le luci e le tenebre di San Patrignano - su questo non ci sono dubbi - sono quelle di Vincenzo Muccioli, in una personalizzazione estrema che salda una sovrapposizione netta tra l’uomo e la comunità. Padre padrone protettivo e manesco, aspirante santone e sedicente guaritore, imprenditore visionario e star dei media idolatrato dalle famiglie dei ragazzi e infine massacrato sotto i colpi di scandali e processi, Vincenzo Muccioli rappresenta il protagonista da manuale, larger than life, di tanta narrativa epica americana. In quanto spettatori siamo chiamati a adottarne il punto di vista e a condividere il peso e la sofferenza di un sogno che si è trasformato in un incubo.
C’è chi ha visto in SanPa un’esperienza rituale quasi catartica, un’immersione nella memoria collettiva e nel subconscio di un’epoca, e chi ha sottolineato la capacità della serie di trattare da adulti gli spettatori, lasciandoli liberi di farsi un’idea grazie alla presentazione di punti di vista diversi e spesso in conflitto tra loro. Se è vero che la messa in onda della serie ha generato una mole considerevole di riflessioni e di analisi di coscienza, individuali e collettive, e ha avuto il merito di riportare a galla il rimosso di una vicenda controversa e dai complicati risvolti politici, non bisogna però dimenticare che quella messa in piedi da Netflix si configura come un’esperienza totalitaria dove lo storytelling e l’efficacia spettacolare del racconto hanno la meglio sulla ricostruzione dei fatti e sulla ricerca della verità. Netflix ha finito con l’imporre un modello di racconto della Storia che nel momento stesso in cui si presenta come trasparente e rigoroso in realtà occulta l’ideologia del suo farsi “discorso”, dove le storie vengono ricomposte nel pensiero unico e nel disegno conformista dell’entertainment. Dove tutto è lecito purché funzioni.
L’approccio corale di SanPa, tanto sbandierato e celebrato, è innanzitutto un’illusione ottica, che se da un lato simula un effetto di complessità, dall’altro non riesce a dissimulare del tutto la sua natura artificiosa. I vari testimoni convocati davanti alla telecamera agiscono in quanto personaggi di un racconto più ampio e sono i portavoce di una storia già scritta altrove - nelle writing rooms all’americana - di cui sono i ventriloqui, le teste parlanti (i talking heads documentaries hanno una lunga tradizione nel mercato anglosassone), in una sorta di straniato e parodico “effetto qui quo qua”, in cui una persona spesso sembra continuare il discorso iniziato da un’altra.
In molti hanno apprezzato la scelta di non usare una voce fuori campo, ma anche qui siamo di fronte a un abbaglio. Cambia poco il fatto che sia una voce a più voci, una voce mostruosa. Sta proprio qui la perizia tecnica di Sanpa - di cui hanno parlato tutti i commentatori, anche quelli più critici, e che innalzerebbe finalmente il prodotto italiano agli standard del mercato internazionale - ossia nell’abilità con cui viene costruita una voce a un tempo composita e compatta, plurale e monolitica, voce di Leviatano che si incarica di portare avanti un discorso unitario che vuole essere prima di tutto accattivante, con un dosaggio drammaturgico oculato che determina la scansione dei turning points e l’entrata in scena dei vari personaggi.
Il racconto scorre fluido e veloce e sembra fuoriuscire con naturalezza dalle risposte delle persone interpellate, con le domande che vengono occultate proprio al fine di non intralciare lo storytelling e di accrescere l’effetto di presa diretta. È un racconto che si perita di nascondere le suture e i raccordi del montaggio e in cui il materiale - 180 ore di interviste registrate e 51 archivi consultati - viene riorganizzato seguendo le logiche di suspense tipiche del crime, con l’intento di ricreare un’esperienza immersiva e di irretire lo spettatore con la seduzione di un congegno narrativo ipnotico, cui decidiamo di soccombere con desiderio e quasi voluttà, scivolando in una sorta di trance. Un sogno ad occhi aperti che ci appaga e ci consola.
Nel fingere di dare voce a tutti si crea un’illusione di profondità e di complessità, ma non c’è confronto dialettico, solo giustapposizione dei punti di vista. E dunque non c’è nessuna progressione verso la verità. E non c’è mai una triangolazione con il fuori rappresentato dal sapere di esperti, siano essi storici o filosofi, medici o psichiatri. Tutti i personaggi sono interni al racconto della comunità ed esistono solo per il tempo del racconto, nella spartizione di luci e ombre. Non deve stupire che c’è chi, concentrandosi solamente sui contenuti, ha visto nella serie un attacco alla comunità e chi invece una santificazione di Muccioli: entrambe le posizioni sono legittime e sono contenute all’interno del racconto. Ogni punto di vista finisce nell’obliterarsi a vicenda con il suo opposto. Ogni ricostruzione è attendibile o inattendibile a seconda del grado di credibilità e di fiducia che siamo disposti a concedere al corpo e alla faccia del personaggio di turno. Lo stesso Walter Delogu, ex autista e guardia del corpo di Muccioli, può essere considerato sia il figlio tradito sia il traditore che non esita a estorcere denaro.
Questo non significa lasciar parlare la Storia, né trattare lo spettatore da adulto, vuol dire piuttosto lasciare lo spettatore solo sulle rive spazzate dal vento del nichilismo, oltre il relativismo postmoderno, dove se nulla è vero allora tutto è permesso, qualsiasi verità è inattingibile e la realtà non esiste, perché non ci sono fatti ma solo storie. Lo spettatore è libero di decidere ma non ha gli strumenti per farlo, chi racconta non si prende nessuna responsabilità, uno vale uno, non ci sono scelte etiche perché non ci sono scelte estetiche, non c’è uno sguardo perché la politique des auteurs si è trasformata in un capitalismo delle piattaforme [11], nella fabbrica cieca di prototipi e replicanti.
Eppure - anche all’interno di un prodotto così levigato - ci sono delle crepe che lasciano trapelare la luce accecante di quello che avrebbe potuto essere se ci si fosse affidati veramente all’ambiguità del reale, uno scalfire le pareti opache del racconto, un tracimare dei corpi e delle personalità fuori dalle rigide maglie dello storytelling contro le finalità dell’entertainment.
Come nel caso di Fabio Cantelli, ex tossico, sieropositivo ed ex portavoce di San Patrignano. Con lo scandalo del suo corpo cristologico, il volto scarnificato e le ossa fragili che reggono i vestiti come stampelle, Cantelli ci parla da una stanza semibuia e disadorna che potrebbe essere un’anonima camera d’albergo o la cella di un monastero, seduto di punta sul bordo estremo del letto in una posizione instabile e precaria, sempre sul punto di caderci addosso e di fuoriuscire dallo schermo. C’è subito uno slittamento, la percezione di una differenza e di uno scarto rispetto alle altre interviste, uno stare scomodi rispetto a tutti gli altri intervistati che sono sapientemente incorniciati dentro gli interni familiari delle loro case, adagiati sopra comodi divani dentro inquadrature geometriche e bidimensionali a testimoniare che loro ce l’hanno fatta, ne sono usciti e si sono salvati, hanno raggiunto quella sicurezza borghese di cui parla Delogu: “da lì puoi costruirti una vita, accedere a un mutuo, riuscire a portare avanti una famiglia, andare a pagare le bollette, cioè fare delle cose che per una persona normale sono normali… per una persona che non ha vissuto quel mondo fare questo è bellissimo”.
Con Cantelli siamo ancora sia dentro che fuori, dentro e fuori la malattia, dentro e fuori la tossicodipendenza, dentro e fuori la comunità. Le sue parole ci conducono lungo un crinale sottile come la lama di un rasoio, in quelle “regioni della vita dove vita e morte sono così strettamente a contatto e quasi intrecciate l’una con l’altra che concetti come libertà, volontà, male, bene vanno rivisti”. Unico personaggio veramente tridimensionale, che quando parla si rifà a una dimensione altra rispetto al qui e ora della cronaca, personaggio dialettico e non contraddittorio, capace di far convivere dentro di sé sia il bene che il male, sia l’amore che l’odio, lui che sa di essersi salvato “grazie a Vincenzo e San Patrignano, nonostante Vincenzo e San Patrignano”.
Allo stesso modo - verrebbe da dire - i momenti più drammatici della serie non sono da ricercare nei colpi di scena da telegiornale né tantomeno nelle ricostruzioni delle vicende più sensazionalistiche.
Prendiamo il caso dell’omicidio di Maranzano, l’evento più tragico e il punto di non ritorno della parabola di Vincenzo Muccioli, nonché acme drammaturgico del true crime orchestrato dagli sceneggiatori. Il racconto dell’assassinio, brutale e violentissimo, ha il compito di spiazzare e colpire emotivamente lo spettatore. Secondo i dettami di un’estetica ultra contemporanea e di un genere ipercodificato, il montaggio interviene a gonfiare l’efficacia sensoriale e l’impatto spettacolare del racconto grazie all’utilizzo di tecniche tipiche del thriller e di una colonna sonora invadente: un montaggio drogato che agisce sottopelle e che, intervenendo direttamente sul nostro sistema nervoso, ci vuole condurre a fare esperienza di emozioni preconfezionate - sorpresa, paura, scandalo, indignazione e dubbio rigorosamente in quest’ordine - senza che ce ne rendiamo conto.
Ma c’è un documento, presentato nella sua nudità di reperto, nella sua incandescenza di materia grezza, che rappresenta forse la scena più straziante dell’intera serie. È un documento che parla da solo e lo fa contro le intenzioni di chi lo ha creato, che non a caso ce lo presenta orgoglioso come un “documento incredibile”. Red Ronnie è venuto a sapere dal suo cameraman dove si trova una ragazza scappata dalla comunità, “che interessa molto a Vincenzo” che l’ha già riportata dentro varie volte. Organizza un incontro, o meglio un’imboscata, in cui intrattiene la ragazza con una finta intervista mentre aspetta l’arrivo di Muccioli. Quando arriva, Vincenzo si rivolge subito al microfono e parla della ragazza come se lei non fosse presente, lei che se ne sta seduta sugli scalini, sotto i due uomini, con la testa tra le mani. Muccioli la solleva di peso e la schiaccia contro il suo corpo immenso, in un goffo tentativo di abbraccio che quasi la soffoca e le parla fissando noi che guardiamo: “Dove vuoi andare? Andiamo, pistolino! Ti senti male? Eh, lo so che ti senti male. Se ti sei bucata con qualcuno dobbiam fare le analisi, eh! Bucalona!”. Le dà tre pacche sul sedere e le chiede un bacio e continua a tenerla stretta mentre lei tra i singhiozzi e con un filo di voce dice: “Non voglio tornare”. Ma quello che dice lei non conta, è solo una bambina che fa i capricci e non sa quello che vuole, per cui a Muccioli non resta che rivolgersi all’amico e a noi spettatori con una battuta: “Eeeh, 'sti figli… Seicento! Troppo prolifico son stato!”. Zio Red se la ride di gusto e saluta Vincenzo con un “Ciao bello!”, mentre lo vediamo sul sedile posteriore della Volvo che riparte con la ragazza.
È una scena che mette i brividi, che non ha bisogno di sottolineature o voci fuori campo. Inizialmente concepito come uno spot, il documento si rovescia nel più grande atto d’accusa nei confronti di Muccioli e del suo metodo. Qui - dove il racconto per un momento sembra rallentare e quasi incepparsi - lo spettatore ha tutto per interpretare quello che vede e per prendere una posizione.
Perché le responsabilità nascono nelle scelte formali ed estetiche, nell’avere uno sguardo politico sul mondo: è questo che consente a Renoir di svelare le regole del gioco che si nascondono dietro una società frivola e perduta, ignara del baratro che nel ‘39 sta per inghiottire l’Europa e il mondo intero. La sua regia restituisce anche a noi spettatori uno sguardo, e al nostro sguardo un corpo, finalmente libero di muoversi nello spazio e nel tempo e di osservare nel montaggio interno e nella profondità di campo [12] dei suoi piani lunghi le relazioni tra i personaggi, e tra i personaggi e la Storia. L’esatto contrario di uno storytelling che incatena il nostro sguardo, che ci obbliga a tenere gli occhi spalancati wide shut, a sincronizzare il respiro e il battito del nostro cuore con quello accelerato del racconto che non ci dà tregua, all’inseguimento impossibile di un’estasi personale che non ha bisogno di altro, come la prima volta che ti fai.
Come diceva giustamente Cantelli, non basta disintossicare un drogato: occorre “costruire un mondo alternativo alla droga che lo interessi, che lo coinvolga e che lo appassioni”. C’è bisogno di ricostruire quel mondo di relazioni che ci aspetta là fuori, oltre il black mirror [13] dello schermo, anche se fa paura.
Note
[1] “Così è nata la mia Sanpa: parla Gianluca Neri, ideatore della docu-serie su San Patrignano”, intervista di Selvaggia Lucarelli su tpi.it
[2] La regola del gioco (La Régle du Jeu), film-capolavoro di Jean Renoir, 1939.
[3] Giorgio Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, 2020.
[4] Franco ‘Bifo’ Berardi, Futurabilità, Produzioni Nero, 2018.
[5] Mark Fisher, Spettri della mia vita, Minimum Fax, 2019.
[6] Sotto il sole di Riccione è il titolo di un film italiano distribuito da Netflix nel 2020, che prende il nome da una canzone dei Thegiornalisti.
[7] Summertime è il titolo di una serie televisiva lanciata da Netflix in pieno lockdown, nell’aprile 2020, che si svolge ed è stata girata nella riviera romagnola, tra Cesenatico e Marina di Ravenna. Netflix ha confermato una seconda stagione.
[8] Gilles Deleuze, L’immagine movimento, Einaudi, 2016.
[9] Gianluca Didino, Essere senza casa, Minimum Fax, 2020.
[10] Chris Vogler, Il viaggio dell’eroe, Audino, 2010.
[11] Nick Srnicek, Platform Capitalism, Polity Press, 2016.
[12] André Bazin, Che cosa è il cinema?, Garzanti, 1999.
[13] Black Mirror è una serie televisiva britannica, prodotta da Charlie Brooker, che descrive con toni distopici gli effetti sulla società delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo dei media.